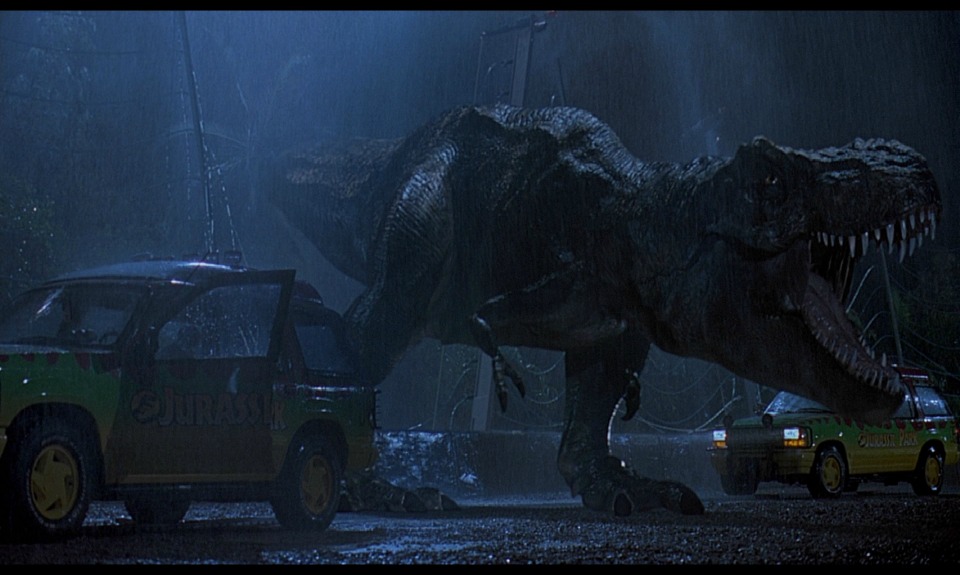«Sono un uomo del XX secolo. Io non voglio affrontare il XXI.»
L’uomo del XX secolo è Hayao Miyazaki, maestro del cinema d’animazione giapponese, spesso riconosciuto come il Walt Disney del Sol Levante. È con questa frase che Miyazaki pare volersi congedare una volta per tutte dal proprio regno, quel regno dei sogni e della follia richiamato dall’omonimo documentario di Mami Sunada, The Kingdom of Dreams and Madness: un viaggio attraverso la nascita dei capolavori indiscussi dello Studio Ghibli, a cui è legato il nome di Miyazaki insieme a quello di un altro grande maestro, Isao Takahata, a cui si deve, oltre al commovente Una tomba per le lucciole (al cinema da novembre 2015, pur essendo del 1988), La storia della principessa Kaguya (2013). Miyazaki ha raggiunto il punto più alto della propria carriera con La città incantata (2001), vincitore dell’Orso d’oro a Berlino nel 2002 e dell’Oscar come miglior film d’animazione nel 2003 (prima e unica volta per un anime), capace di superare al box office nipponico persino Titanic. Ma non si devono trascurare altri indimenticabili film come Nausicaa della Valle del Vento (1984), Laputa – Il castello nel cielo (1986), La Principessa Mononoke (1997) e Il castello errante di Howl (2005), fino ad arrivare a Ponyo sulla scogliera (2008) e Si alza il vento (2013).
Ma The Kingdom of Dreams and Madness non racconta la carriera di Miyazaki e Takahata. Si tratta piuttosto di uno sguardo iperrealistico, in presa diretta, sul funzionamento dello Studio Ghibli: i ritmi intensi, l’assegnazione del ruolo da protagonista a Hideaki Anno, i pensieri di Hayao stesso, il lavoro di Takahata (che compare solo fugacemente), una sessione di doppiaggio di Si alza il vento che porta Miyazaki alla commozione… Il cineasta giapponese è uno che sa come si lavora sodo (lo fa ogni giorno, dalle 11 alle 21, esclusa la domenica), e che esige la cura di ogni minimo dettaglio. Una cura maniacale che gli ha portato via cinque anni, perlomeno per realizzare il suo ultimo film, Si alza il vento, presentato al Festival di Venezia nel 2013. Sarà l’ultimo in tutti i sensi e The Kingdom of Dreams and Madness è il diario di quest’ultima fatica, incominciato nel 2012 e concluso nei primi mesi del 2013. La regista Mami Sunada ha detto che la Disney Giappone voleva farle fare un dvd commerciale sullo Studio Ghibli, ma una volta entrata nella regno del fantastico duo Miyazaki-Takahata si era resa conto che quell’ultimo anno sarebbe stato molto diverso dagli altri, e così aveva optato per un documentario. La premiere di The Kingdom of Dreams and Madness si è tenuta durante il Festival di Toronto del 2014, ma il film è stato reso disponibile in dvd o in video on-demand soltanto dal 27 gennaio 2015.
«Ci sono molti documentari sullo Studio Ghibli che in Giappone sono stati trasmessi in tv», ha detto Mami Sunada. «Per questo quando il signor Suzuki [produttore ed esecutivo dello Studio Ghibli, ndr] prende una decisione, ciò che chiede è: “Che cosa si può fare di nuovo?”. In quest’anno davvero insolito e indimenticabile sono stati fatti sia Si alza il vento sia La storia della principessa Kaguya, quindi ho deciso che sarebbe stato proprio questo su cui avrei incentrato il documentario – il confronto tra i due registi, il loro storico rapporto professionale – e come ognuno occupa il proprio posto nello studio. Questa era la cosa su cui volevo soffermarmi.»
Miyazaki non scrive copioni ma storyboard, e i suoi assistenti iniziano la produzione da questi disegni prima che lui li abbia finiti. Quando accoglie Sanada nella sua casa-studio, Miyazaki filosofeggia sull’arte e sull’umanità per sentirsi come qualcuno che viene a patti con il lavoro di una vita. E così parla dolcemente del suo modo di fare film, in particolare di come la famiglia dello Studio Ghibli vede il cinema. In Si alza il vento c’è qualcosa di talmente personale da portarlo alle lacrime dopo l’anteprima: è la prima volta per un suo film.
Si alza il vento è un film biografico sui sogni “belli ma maledetti” di Jiro Horikoshi, un ragazzino miope che progetta aerei, non potendo pilotarli. Proprio Miyazaki, da piccolo, sognava il volo. Sognava che il suo corpo sfiorasse le nuvole sulle città giapponesi di Utsunomiya e Kanuma, dove era cresciuto; in altri sogni, la magia lo avrebbe improvvisamente tagliato fuori, e lui avrebbe fatto un giro su se stesso e sarebbe sfrecciato verso il basso, risvegliandosi con un salto prima di toccare per terra. Suo padre, Katsuij, gestiva una compagnia chiamata Miyazaki Airplane, che produceva alette di coda per aerei da combattimento giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. In occasione di una visita alla fabbrica, il giovane Hayao fu incantato dalla bravura meccanizzata delle parti, per esempio il modo in cui un filo si univa a un albero e gestiva un timone. Ma non riusciva a collegare in modo consapevole gli oggetti che suo padre faceva ogni giorno e ciò che sognava.
«Nella mia testa, erano totalmente separati», ha detto il regista. «Probabilmente si tratta di un ottimo caso di studio psicoanalitico. Amavo gli aerei perché erano delle macchine incredibili, ma la velocità e l’altezza del volo – queste erano cose che capivo subito, da bambino. Penso che un sacco di persone abbiano fatto i miei stessi sogni.» Del film in sé per sé, però, ce n’è ben poco. Sanada concede qualche spezzone di Si alza il vento solo in fase di montaggio: d’altronde questo è molto più che un semplice documentario su un anno di vita dello studio. Il film di Sanada, non a caso, riesce a dare il meglio di sé quando la regista trasmette la consapevolezza che si tratta di uno studio e di una voce creativa in un periodo di transizione e forse nella sua fase crepuscolare. La musica, il tono, l’oggetto dei due film, la candida riflessione di Miyazaki – tutto concorre a dipingere il ritratto di qualcosa di meraviglioso che sta per finire. E il ritratto che ne emerge non è soltanto quello di un regista che ama ciò che fa ma anche delle persone che sono coinvolte nel processo creativo e che, ognuno nel proprio piccolo, contribuiscono a trasformare una faticosa catena di montaggio in qualcosa che sembra avere vita propria. Perché i personaggi di Miyazaki e Takahata riflettono la straordinaria umanità e la sorprendente sensibilità dei loro creatori.
Sunada, che in precedenza aveva lavorato come aiuto-regista in alcuni film di Hirokazu Kore-Eda e a una manciata di altri progetti, si rende conto che c’è una buona ragione per cui questo film esista ben al di là del fatto che si possa realizzare. Il suo documentario non è solo un lamento per la fine dello Studio, ma tende ad anticipare la fine stessa: e così, dal primo giorno in cui inizia le riprese nello Studio Ghibli, Sunada è fin troppo consapevole che il suo sarà un elogio. Quando confessa che «il futuro è chiaro: cadrà a pezzi», è come se Miyazaki leggesse dal copione. Se però lo immaginate come un nonnetto adorabile dagli occhi splendenti di meraviglia, potreste restare delusi. Dal film di Sunada emerge un uomo molto diverso: un uomo cortese e un operaio diligente benedetto da un colpo di genio. Ma è un uomo segnato allo stesso tempo da momenti di cinismo, risentimento e insicurezza che alludono a qualcosa di cupo dietro alle sue creazioni. «Non mi sono mai sentito felice nella mia vita quotidiana», dice. «Il cinema porta solo sofferenza.»