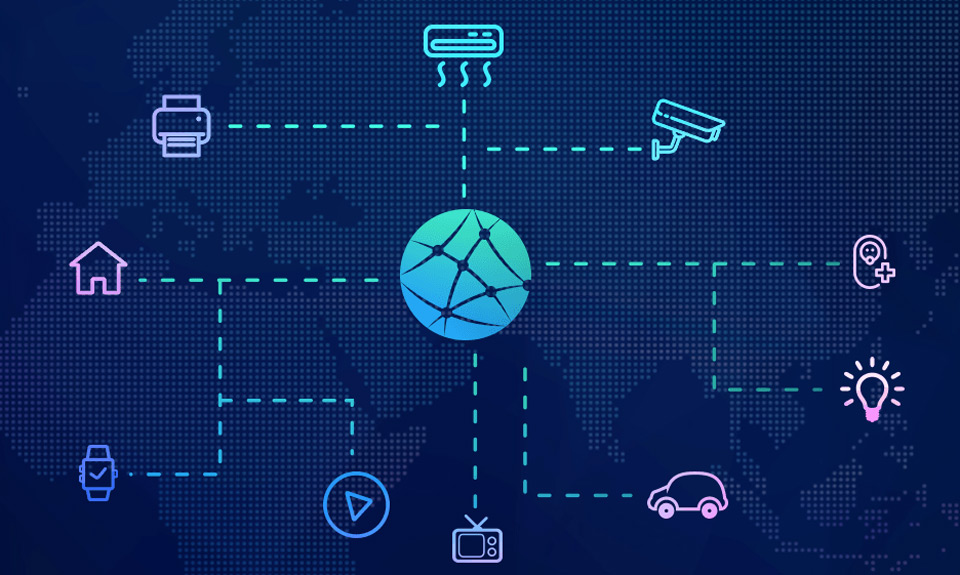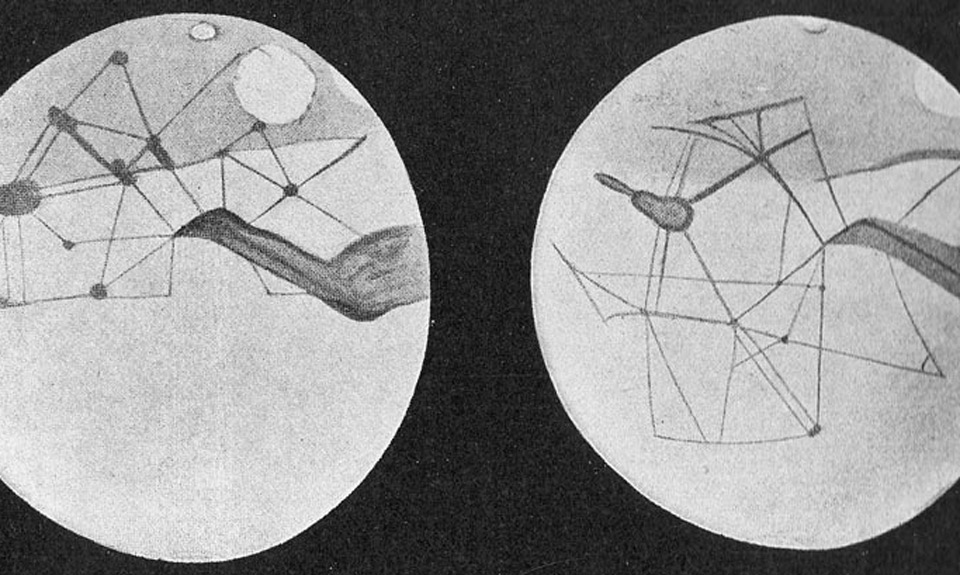In questi giorni stiamo veramente sentendo di tutto sulla questione referendaria.
Di tutto, soprattutto quello che non c’entra, che non informa, che non si dice.
E allora provo a fare un po’ di ordine.
Questo è il primo referendum proposto dalle regioni contro una misura del governo nazionale.
Come ha spiegato l’Espresso “i quesiti referendari proposti dalle Regioni erano sei. Ora ne è rimasto solo uno, visto che nel frattempo il governo ha sterilizzato gli altri con delle modifiche all’ultima legge di stabilità. I cinque quesiti saltati puntavano a restituire agli enti locali un ruolo rilevante nelle decisioni sullo sfruttamento di gas e petrolio. Ruolo ridimensionato con la legge Sblocca Italia, voluta da Renzi con l’obiettivo di velocizzare i processi autorizzativi nel settore, fra i più lenti d’Europa. Con le modifiche alla legge di Stabilità, insomma, il governo è tornato sui suoi passi restituendo alle Regioni il potere originario.”
Quindi la prima cosa che c’è da sapere è che spenderemo 300milioni di euro per un referendum su un solo quesito, che anche per le regioni, in origine, era di marginale interesse.
Ed anche se poteva essere accorpato alla votazione per le amministrative in molti comuni, si è scelto di non farlo (non è vero che non si poteva) per una ragione che vedremo poi.
Noi elettori saremo chiamati a votare su una questione piuttosto tecnica.
Non che siamo analfabeti, ma il principio referendario è differente: esprimere il voto su una questione chiara, su cui i cittadini devono essere ben informati, e non certo su una materia estremamente tecnica. Un esempio chiarissimo è il primo referendum repubblicano tra monarchia o repubblica.
Cosa ci viene chiesto?
Dovremo decidere se i permessi per estrarre idrocarburi in mare, entro 12 miglia dalla costa, possano durare fino all’esaurimento del giacimento, oppure fino al termine della concessione.
Vanno chiariti due punti.
Il primo è che già oggi è prassi che la concessione venga “estesa in deroga” in tutti i casi in cui viene richiesto dalla compagnia petrolifera. Sarebbe quasi insensato il contrario.
Il secondo riguarda l’inserimento del termine nella concessione: quel termine serve a due scopi.
Il primo è evitare l’accaparramento di concessioni. Se non ci fosse un termine io potrei acquisire un certo numero di concessioni “senza scadenza”, non estrarre, e rivenderle quando e come voglio, in sub-concessione. E potrei “occupare” tutte le concessioni possibili, anche senza estrarre, evitando che altri possano farlo.
Il secondo è che inserendo un termine le compagnie hanno “interesse ad estrarre” sempre, mentre non avendo una scadenza, potrebbero decidere di estrarre solo quando i prezzi sono alti. E mantenere estrazioni minime o nulle in altri momenti.
Il termine – che esiste in tutto il mondo e in tutti i paesi – tende ad evitare questi accaparramenti e queste speculazioni.
Alcune cose che “ci dicono” e che non sono del tutto vere.
Ci dicono che se il referendum dovesse passare le piattaforme piazzate attualmente in mare a meno di 12 miglia dalla costa verranno smantellate una volta scaduta la concessione, senza poter sfruttare completamente il gas o il petrolio nascosti sotto i fondali.
Non è vero. Intanto perché l’estensione della concessione, o il rinnovo con altro termine è sempre possibile, poi sarebbe sempre possibile una nuova concessione. Nessuno è così malato di mente da lasciare un giacimento, perforato, ancora utile.
Ci dicono che si perderebbero migliaia di posti di lavoro.
Anche questo non è vero. Perché sono pochissime le concessioni di cui parliamo, e perché parliamo comunque di giacimenti teoricamente già ampiamente sfruttati e che occupano pochissimo personale diretto (mentre l’indotto è comunque garantito dalle quasi 150 piattaforme comunque esistenti).
Alcune cose che non c’entrano affatto, ma che ci sono entrate di prepotenza.
Ci dicono che sia un referendum tra “idrocarburi e rinnovabili”.
Non è così. La scelta delle forme di approvvigionamento energetico è in altra sede (anche normativa) e semmai lì andrebbe fatta questa – giusta – battaglia. Consapevolmente.
E tuttavia non ho visto nessuno, nemmeno di quelli che ne parlano, aver presentato proposte di legge concrete, ad esempio, per ampliare e rinnovare incentivi in questo senso. Ma forse mi è sfuggito.
Ci dicono che “c’entra Tempa Rossa”.
Non è così e comunque non avrebbe niente a che farci, dal momento che si tratta di un giacimento estrattivo terrestre.
Il caso tuttavia merita un chiarimento: da un lato il governo ha fatto un giusto provvedimento perchè non si può pensare di bloccare un investimento da complessivi tre miliardi di euro perchè “devi passare” dal placet (e quindi dall’accordo, anche degli interessi economici) di ogni singolo comune, anche il più piccolo. Dall’altro però non si può pensare dopo tanti scandali ecologici, che in quello stesso provvedimento – di fatto e di diritto – le compagnie petrolifere siano “esentate” da qualsivoglia responsabilità ambientale e danno e risarcimento, solo per sveltire. Se dunque in qualche modo Tempa Rossa ce la vogliamo fare entrare, è proprio come esempio semmai di un eccesso di confusione all’interno del quale, con cose giuste, finiscono dentro anche tante cose sbagliate. Un po’ come in questo caso referendario.
Ci dicono che la quantità energetica prodotta da questi giacimenti sia irrilevante.
Non tanto. Parliamo del 3% del nostro fabbisogno di metano e dell’1% di petrolio. E dato che siamo – ancora – tra i sette paesi più industrializzati, quell’1% e quel 3% sono soldi. Parecchi. Non tanto e solo per fare cassa, quanto come scorte e per calmierare, almeno qualche volta, il mercato. Oltre che fruttano circa 1 miliardo di euro all’anno come imposte a vari gradi di enti (dallo Stato ai comuni).
Ci dicono che le trivelle inquinano.
Intanto il referendum non chiede l’abolizione di ogni forma di installazione marina. Quindi non si comprenderebbe il nesso. Se poi è vero che – come tutti possiamo intuire – fare un buco in mezzo al mare, piantare componenti in cemento armato, ferro, acciaio e quant’altro non è proprio il massimo dell’ecologia, è anche vero che – in questo caso – la tecnologia italiana e l’attenzione sono elevatissime. Anzi, proprio gli elevati controlli spesso assicurano un elevato grado di informazione e sicurezza, in un raro caso in cui l’interesse ambientale è anche interesse del soggetto titolare della trivella.
Le famose cozze attorno ai piloni: da una parte è normale che ci siano, dall’altra semmai “puliscono” e di certo sono un indicatore ambientale.
Morirebbero in caso di avvelenamento da idrocarburi o similari e altrettanto non risulta che nessuna analisi effettuata vi abbia trovato patologie che le rendano addirittura tossiche.
Che poi, come detto prima, le trivelle, in sé non sono “naturali” è un fatto. Come un fatto che questo referendum non le abolisce. Come un fatto che – purtroppo – da nessuna parte vengono richiesti (e presentate proposte di legge in tal senso) per aumentare i controlli e la sicurezza. Da nessuna delle parti referendarie.
Il nodo politico di questo referendum.
Come successo spesso in passato, anche questa volta questo referendum si è connotato da uno scontro politico tra maggioranza e opposizione.
Come se fosse un referendum sul governo, e già sappiamo che qualsiasi sarà il risultato in questa direzione andrà il dibattito, non certo su ecologia, trivelle ed energia.
La “nuova politica” rispolvera quel Craxi della prima repubblica che invitò i cittadini ad andare al mare. E così assistiamo al triste invito del Presidente del Consiglio (e tacitamente governo tutto) a non andare a votare, in quella strana accezione per cui “coloro che non votano appoggiano l’operato del governo”.
Tristezza che cresce se su questa posizione si schiera anche l’ex Presidente della Repubblica, perché un Presidente Emerito che invita al non voto, davvero, non lo si era ancora mai visto.
E che non si arrivi al quorum è abbastanza probabile, visto il clima, l’interesse, il tema sin troppo specifico.
Che questa possa essere considerata una vittoria per qualcuno non credo affatto. E lo dico prima.
Di certo, come detto all’inizio, spenderemo 300milioni che potevamo risparmiare.
E li spenderemo perché interesse politico di una parte è che non si vada a votare.
Se dovesse passare il Si (ovvero l’abolizione di questa norma) tutti griderebbero “Renzi a casa”.
E cosa c’entra questo con un popolo che ogni volta che ha potuto si è sempre espresso – talvolta anche masochisticamente – per scelte quanto più ecologiste possibili?
Ma in questo caso se passasse il Si, a guardare la norma, cambierebbe poco, o nulla.
Se dovesse passare il No (ovvero la norma rimarrebbe com’è) anche in questo caso cambierebbe ben poco rispetto anche a prima che la norma entrasse in vigore.
Certo era un referendum evitabile. Così come lo scontro politico che ne è scaturito.
Ma è solo uno “scaldare i motori” in vista del Referendum Costituzionale di Ottobre.
Ed anche in quel caso, la comunicazione politica vuole che si trasformi in un muro contro muro, pro o contro il governo, e non certo in un’analisi ponderata di cosa dice quella riforma.
E questo sarà un male, perché si può anche essere a favore del governo, ed essere critici verso questa o quella misura.