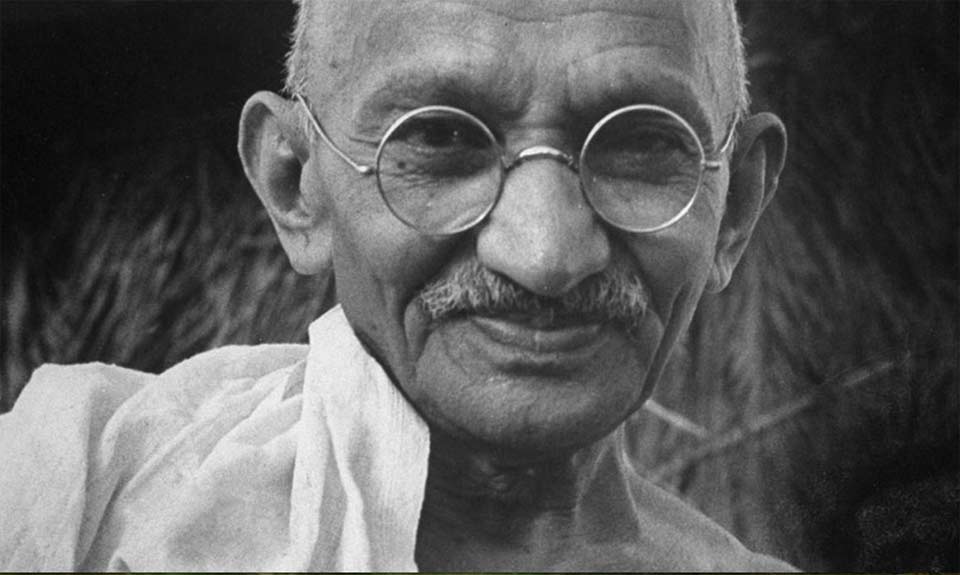Raggirati. È questo l’hashtag che, su twitter, sintetizza e racconta le vicende di questi giorni sull’amministrazione del M5S a guida Virginia Raggi.
“Ho capito bene? Il sindaco M5s di Roma ha detto che deciderà sul suo assessore, indagato per falso e abuso d’ufficio, dopo aver letto le carte? A chi si affiderà la Raggi per emettere la sentenza? Ad un giudice, ad un avvocato? E poi quale sarebbe il suo diritto ad avere le carte di una inchiesta, teoricamente coperta in parte da segreto istruttorio? Barzellette capitoline!” sintetizza Fabio Postiglione.
“Il Fatto in edicola dice che la Raggi o si dimette o chiede scusa. Eh no, troppo comodo, miei cari. L’avete creata voi. C’e concorso di colpa. Facciamo che lei si dimette e voi vi scusate, tanto per cominciare.” è il commento di Aldo Trochiaro.
“Nessuna conferenza stampa, non una dichiarazione in consiglio o una spiegazione che sia una in Campidoglio. Arriva un messaggio della sindaca su un blog di un privato, una dichiarazione sterile dove non spiega nulla in merito al caos istituzionale che sta avvenendo a Roma. Uno scempio politico mai visto.” è la chiosa di Tommaso Ederoclite.
Ma un commento apre la questione ad un differente punto di vista, a firma di Andrea Iannuzzi
“Consiglio non richiesto al Pd (romano e non): ma perché invece di assistere buoni buoni ai pasticci che combinano i 5 stelle, bravissimi a farsi male da soli, continuate a parlare male di loro e ad attaccarli? In questo modo ottenete solo l’effetto di ricordare ai cittadini i disastri che avete combinato voi. Godete in silenzio, se ci riuscite”.
La notizia riportata sull’Huffington Post non è un caso isolato. Scrive Gabriella Cerami “L’Armageddon dei 5 Stelle, almeno a Roma, è rappresentato da una mail che la sindaca di Roma Virginia Raggi avrebbe inviato a Luigi Di Maio e al mini direttorio – Paola Taverna, Gianluca Perilli, Massimo Castaldo e Stefano Vignaroli – per informarli che l’assessore all’Ambiente Paola Muraro era iscritta nel registro degli indagati e che l’intenzione del Campidoglio era quello di attendere le carte e “poi prenderemo provvedimenti”. Mail che rappresenterebbe la prova che anche Luigi Di Maio era a conoscenza, da tempo, dei guai giudiziari dell’assessore capitolino, comunicati alla diretta interessata il 18 luglio e appresi dalla sindaca il giorno successivo. E quindi il gruppo dirigente dei 5 Stelle avrebbe omesso e depistato sul coinvolgimento di Muraro, per dodici anni consulente dell’Ama, nell’inchiesta sui rifiuti. E chi attendeva la prima puntata di Politics su Raitre per conoscere la posizione di Luigi Di Maio resterà deluso, perché non si presenterà.”
Qual è dunque il tema di questo Movimento 5 Stelle che si è presentato come “rinnovamento”, fuori dalle logiche della vecchia politica, con “onestà e trasparenza” prima di ogni altra cosa, con gli streaming per tutto e su tutto divenuti sempre più occasionali sino a scomparire?
Conta che “su tutto decide la rete” sia diventato un direttorio scelto da Beppe Grillo che decide in chiuse stanze? Conta ancora che quegli scontrini pubblicati per i primi mesi siano spariti da un anno?
Conta davvero che – ancora – non ci sia un bilancio pubblico del Movimento 5 Stelle, con un tesoriere, che non ci sia un’assemblea degli iscritti, che – nonostante le sentenze dei tribunali – non siano previste forme di gestione e ammissione del dissenso interno?
E le menzogne e le coperture, sono davvero ancora fatti occasionali? Su Parma il direttorio “non sapeva”, e poi Pizzarotti ha reso pubblici i messaggi e le mail inviate, tutte senza risposta, ma in cui informava ampiamente… su Quarto il trio Fico – Di Maio – Di Battista è apparso in streaming per affermare di non sapere, anche qui smentiti da mail e messaggi. Sapevano e come!
Adesso è la volta di Roma.
Si sapevano. Sapevano ogni cosa. Sapevano delle indagini, delle inchieste, e sapevano soprattutto chi erano quelle persone, da quali ambienti provenivano, quali erano i rapporti personali, professionali e politici pregressi. Sapevano. Hanno mentito, nascosto, sino alla farsa del “complotto dei palazzinari pro olimpiadi”. Sino a quel “se indagano altri, dimissioni subito” ma se indagano uno dei loro, allora è bene leggere le carte. Si, e decidere senza competenze, sostituendosi ai giudici.
L’onestà andrà di moda. E la trasparenza pure. Ma il futuro non è adesso. Almeno nelle aministrazioni 5 stelle.
Ma tutte queste non sono buone notizie. Non lo sono per i romani e per Roma. Non lo sono per le persone in perfetta buona fede che, semplicemente, volevano di meglio, volevano altro. Forse solo volevano rispetto. Ma non sono buone notizie nemmeno per i cari vecchi partiti, di centro destra quanto di centro sinistra.
Ancora oggi, nonostante tutto, se si tornasse a votare a Roma (come altrove) i disastri, le menzogne, la mancanza di trasparenza, il piccolo potentato di pochi che ormai è cosa palese, il fatto che Grillo fomenti la folla e poi si lavi le mani di tutto, non sono sufficienti a far cambiare idea alla maggior parte dell’elettorato.
La ragione è semplice ed è politica.
Non si vince per mancanza di avversari o per la scelta del meno peggio.
La chance dei partiti è ampia, ma a quanto pare sarà ancora un’occasione persa per un vero e profondo rinnovamento e per prendere di petto quella questione morale mai affrontata dai tempi di Berlinguer.
Non bastano gli sfaceli, né che il Movimento 5 Stelle, da solo, mostri ciò che è oltre gli infingimenti di una propaganda tossica e violenta della rete.
Occorre un vero, serio, profondo rinnovamento dei partiti, con spazi a persone nuove, senza pensare – con la solita arroganza e presunzione – che “si può fare ancora un altro giro”.
Autore: Michele Di Salvo
Satira e democrazia
La realtà ti frega sempre. È una vecchia battuta satirica. Ma dietro questa battuta della satira sulla satira c’è una verità ancora più profonda e disarmante. La satira moderna, nata in Francia con i primi giornali e subito esportata in Inghilterra, altro non è che la rivisitazione di quei giullari che erano gli unici che “si salvavano la testa” avendo la facoltà di dire al Re come stavano le cose, senza filtri e senza diplomazie. Un salvacondotto che ha attraversato i tempi dall’antica Grecia, ai riti del carnevale, attraverso i versetti murali. Un toccasana catartico per il popolo, una scintilla di democrazia anche in tempi della storia quando la democrazia non c’era.
Perché i potenti di ogni tempo la tolleravano? Per il semplice motivo che a chiunque, qualsiasi sia il sistema di Stato e di Governo, occorre una cartina di tornasole in grado di restituirci come stanno le cose, oltre gli opportunismi dei cortigiani di ogni tipo e tempo storico.
In tempi di democrazia la satira è più dirompente e pericolosa, forse perché il potere del Re è meno certo, meno ereditario, più discutibile. E se la qualità della classe politica scende, allora la satira fa ancora più paura. Vista così la satira è la cifra della salute della democrazia, e della qualità di una classe politica e dirigente. Reagire male, censurare, sdegnarsi, parlare di buon gusto, sono tutti indici di fragilità. E questo, per un popolo consapevole, dovrebbe essere un altro campanello d’allarme, perché rischia di essere l’anticamera, quando non della dittatura, certamente di norme liberticide.
Già quest’estate il ritratto del ministro Boschi da parte di Riccardo Mannelli “lo stato delle cos(c)e” ha suscitato reazioni sessiste. Il disegnatore ci restituiva il rischio che, dietro la facciata di tanti discorsi, mancasse la sostanza nel più ampio dibattito su una riforma cruciale come quella dell’ordinamento costituzionale, e che restasse solo l’apparenza.
A poche settimane da quell’episodio è di oggi l’indignazione per la vignetta di Charlie Hebdo. Vittime del terremoto rappresentate come “piatti di pasta”. Cosa diceva quella vignetta, e cosa ci voleva ricordare? Qualcosa di anche troppo banale: che per qualcuno, quei morti, quelle case, altro non sono che “un piatto da, e in cui, mangiare”, e che spesso molti di quei morti lo sono proprio perché su quei lavori edili qualcuno ha abbondantemente mangiato.
Una politica sana avrebbe capito, compreso. Non si sarebbe indignata per una vignetta (bella o brutta non conta). Avrebbe ad esempio ricordato le intercettazioni della notte del terremoto de L’Aquila, dove la realtà che supera la satira ed ogni macabra fantasia, ci restituiva davvero commensali festosi intenti a pensare solo al prossimo banchetto. Tutti assieme: politici, tecnici e costruttori.
Una politica sana nasce da un popolo consapevole, e un popolo consapevole avrebbe compreso quella dura vignetta che come un pugno nello stomaco ci ricordava una realtà più cruda della satira. E una politica sana avrebbe risposto semplicemente e fermamente: “grazie per averci ricordato qualcosa di tragico avvenuto nel passato, e faremo di tutto perché non si ripeta”.
In tempi privi di democrazia il Re avrebbe capito, non avrebbe risposto o replicato, avrebbe forse riso (meno i suoi cortigiani affaristi) e la testa del giullare sarebbe stata salva.
In tempi di democrazia invece, in cui esiste la libertà di stampa “pro domo nostra”, a quanto pare la politica debole risponde con sdegno e scarsa memoria. Paladini della libertà di espressione propria, dimenticano con troppa leggerezza quella altrui.
Perché libertà di stampa – va chiarito in tempi di democrazia debole – non è “la mia libertà di dire ciò che voglio” quanto difendere il diritto altrui, soprattutto di chi è decisamente distante dalle tue idee, di essere libero di affermarle.
La buona notizia però c’è. Ieri un quotidiano nazionale vicino proprio a quei faccendieri che hanno speculato e mangiato su L’Aquila (Libero) ha replicato alla vignetta di Charlie Hebdo con il seguente titolo a tutta prima pagina “verrebbe voglia anche a noi di sparargli”. Ecco, significa che la satira chi ha decisamente “azzeccato”, e che ancora una volta la realtà supera la satira (e che qualcuno anche nel mondo dell’informazione non ha ben chiaro il proprio ruolo).
Come cambierà il sistema bancario italiano?
Cosa sta accadendo nel sistema bancario italiano?
Ci sono notizie che solo apparentemente sono separate e indipendenti tra loro, ma che delineano uno scenario preciso. Proviamo a mettere insieme i pezzi.
Intanto la crisi di Monte dei Paschi di Siena, storica banca toscana che per ragioni principalmente di potere locale e interessi particolari non ha mai fatto parte del giro delle grandi fusioni bancassicurative degli scorsi vent’anni, quando forse sarebbe stato il momento non solo opportuno da un punto di vista di mercato, ma anche e soprattutto sotto il profilo industriale in prospettiva di crescita.
Forse, anche in questo caso, tuttavia, occorre chiedersi se la volontà non fosse proprio quella di evitare – come accaduto in varie occasioni – che si formasse un altro gruppo capace di contendere le posizioni decisamente dominanti di Intesa e Unicredit, ad esempio.
Altro tema aperto è quello dei piccoli istituti di credito in crisi (Banca Etruria…).
Questi quattro casi sono rilevanti per almeno tre motivi.
Il primo è che si tratta del primo test italiano dell’era euro di messa in liquidazione di istituti di credito, ed è un test perfetto per verificare la tenuta della nostra normativa nazionale rispetto alle regole europee finanziarie e monetarie.
Il secondo, è che questa è stata l’occasione per mettere mano al settore bancario ponendo l’accento sulla necessità di aumentare la patrimonializzazione e la capitalizzazione soprattutto degli istituti di medie e piccole dimensioni.
Il terzo, è che è stata l’occasione per mettere in piedi, presentandola come misura urgente e necessaria, il sistema del cd. fondo Atlante, ovvero quello strumento che consente e consentirà alle banche di “cedere” gran parte del passivo, ripulendo i propri bilanci per complessivi 150 miliardi di euro.
Poi c’è la questione della prevedibile fusione delle banche popolari. Sia per le ragioni già dette, sia per le nuove normative, sia – soprattutto – per esigenze di mercato: per essere in grado di rispettare parametri patrimoniali e di capacità di erogazione.
Tutti i punti, apparentemente slegati tra loro, di cui abbiamo parlato riaprono il grande tema – in Italia particolarmente delicato – delle grandi acquisizioni, specie in materia bancaria.
In questo settore la storia del nostro paese è letteralmente divisa in tre.
Da una parte gli istituti legati ai grandi gruppi industriali (Credito Italiano, San Paolo di Torino, Banca di Roma, Mediobanca, Mediolanum) da un’altra le grandi banche legate allo sviluppo locale (Monte Paschi, Banco di Napoli, Banco di Sicilia etc) ed infine la galassia delle banche provinciali, legate alle storie dei comuni e delle provincie, in un’epoca in cui il nostro paese era prevalentemente agricolo e basato sulla piccola impresa locale (e qui la galassia delle casse di risparmio e delle popolari è frastagliata quanto la penisola).
È evidente che questo sistema non può reggere né alla moneta unica, né all’Europa Unita, men che meno al mondo globalizzato in cui sono chiamati ad operate gli istituti di credito quanto – e prima – le imprese.
Ammodernare, rendere solido, rendere competitivo il sistema del credito è necessario quanto una infrastruttura nazionale e una riforma istituzionale.
E tuttavia la maggiore resistenza – e il massimo grado di incertezza e di rischio di mancanza di trasparenza – nasce proprio dagli interessi locali che vedono minate le posizioni di piccolo potere territoriale. E il tema riguarda la politica quanto il mondo dell’impresa.
A leggere i bilanci, le delibere estive dei consigli di amministrazione, le decisioni in termini di riserve e accantonamenti, lo scenario dei prossimi mesi (orientativamente da settembre a marzo) sarà più o meno il seguente.
Unicredit probabilmente acquisirà MPS.
Un percorso tracciato da tempo, da quando Alessandro Profumo (vicino a Renzi), artefice e creatore del primo gruppo bancario italiano, andò proprio in MPS come Presidente. In una situazione complessa, in cui almeno riuscì a evitare la chiusura del’Istituto, che se oggi è in difficoltà ma acquisibile è anche un po’ grazie a lui.
Banca Intesa probabilmente acquisirà il polo delle banche popolari.
Un percorso più lungo che prevede prima la creazione di un unico gruppo, alla cui testa UBI e Popolare di Milano e a seguire tutte le altre. Un percorso tra le righe avviato con quel ruolo apparentemente marginale ricoperto da Bini Smaghi…
Le due operazioni, sostanzialmente dovrebbero avere la stessa dimensione finanziaria, il che lascia intendere più o meno che insieme con MPS ci potrebbe essere qualche altro tassello da inserire, e che probabilmente nei conti finirà molto altro, esattamente come è evidente che prima della costituzione del gruppo delle popolari sarà molto alto il debito che verrà ceduto al fondo Atlante.
Questo per restare nei termini della sostenibilità e solidità delle fusioni da un punto di vista finanziario e contabile. E non senza un forte alleggerimento (in totale circa 60miliardi) del passivo totale di Intesa e di Unicredit.
Queste operazioni non saranno così semplici.
Dovranno fare i conti con i placet europei, con le normative antitrust per evitare eccessive concentrazioni. Probabilmente (come fu per Intesa, Banco di Napoli, Cariparma) sarà necessaria la cessione di molti sportelli per ciascuno dei due gruppi.
Ma è necessaria anche per difendere i nostri istituti di credito da scalate da parte di banche estere.
Nello specifico da un alto abbiamo i tedeschi e alcuni gruppi francesi, dall’altro abbiamo le banche inglesi, che dopo la Brexit hanno la necessità di riposizionarsi finanziariamente sui mercati europei.
E se la BCE con gli stress test ha messo qualche paletto a DeutchBank e Societé Generale, di certo non potrà impedire ad altre grandi banche di acquisire (a prezzi modici e in nome della libera concorrenza europea) la rete degli “sportelli in eccesso” derivanti dalle fusioni.
Non sono tutte brutte notizie, o notizie poco rilevanti per i comuni cittadini.
Ad esempio paradossalmente, con l’ingresso di nuovi gruppi europei ci sarà maggiore concorrenza. E questa concorrenza avverrà tra istituti molto più solidi in cui sarà molto più difficile che i risparmiatori e gli azionisti si ritrovino con gli stessi rischi degli ultimi due anni.
Avremo un sistema meno differenziato: questo significa che servizi, prodotti e condizioni saranno più simili, anche se commercialmente le banche dovranno fare qualcosa per attrarre clienti.
In più – per chi avesse qualche euro da investire ragionando ad almeno uno o due anni – è un buon momento per acquistare azioni bancarie… che poi finisce che gridiamo al complotto, di leggi che favoriscono i grandi finanziari che queste analisi le hanno già fatte.
Renzi e la comunicazione referendaria
Sembrerebbe che – lentamente, e forse con ritardo – Matteo Renzi si sia reso conto che era necessario cambiare verso alla comunicazione politica verso il referendum costituzionale.
Commentando l’esito del referendum sulle trivelle scrissi:
“Se la campagna sarà sul testo referendario, Matteo Renzi può sperare di mobilitare quei 6 milioni di votanti che non votano Pd e che vogliono comunque le riforme.
Ma se la campagna referendaria – come invece chiaramente faranno i suoi avversari – non sarà sul tema del referendum, ma su un voto pro o contro Renzi, è molto probabile che la somma delle varie minoranze tra Sel, Sinistra Italiana, FdI a tutto il frammentato centrodestra, alla Lega di Salvini al Movimento Cinque Stelle e quanti altri, nonché la minoranza interna del suo stesso partito – sarebbero, matematicamente, ben più di quei 10 milioni.
Perché il Pd che si attesta al 33-35% è ben lontano da quel partito della nazione capace di vincere da solo. E “fuori” da quel Pd c’è una maggioranza eterogenea incapace di mettere insieme una maggioranza parlamentare, ma che comunque assomma al 65% dei voti reali.
Ma il vero problema è che sinora Renzi sembra incapace di fare una campagna non-manichea, che non polarizzi tra “con me o contro di me”, che non sia “assoluta” e che non veda “ottimisti contro gufi”.
E quindi il vero rischio – numeri alla mano – su un referendum che lo stesso Renzi potrebbe davvero vincere, è che invece lo perda, per colpa dei suoi stessi limiti comunicativi (che invece in altre occasioni sono stati il suo punto di forza).”
Oggi il problema è duplice.
Da una parte i sondaggi non danno il suo Pd e la sua leadership ai livelli di quel 40%, e contemporaneamente la minoranza interna – che compattata non è poi così irrilevante – è pronta a votare no se non verrà messa mano alla legge elettorale.
Dall’altra c’è la presa d’atto che le opposizioni (che insieme non hanno i numeri per governare) compattate su un semplice quesito possono arrivare al 65%, praticamente doppiando i numeri del Si.
A questo calcolo, per ora solo numerico e “da scrivania”, se ne aggiunge un altro, e non di poco conto. Il fronte del No non ha neanche cominciato la sua campagna, mentre il governo ha speso mesi a dichiararla “la madre di tutte le battaglie”.
Finanche la normale, consueta, rituale alternanza dei direttori dei Tg è finita nel tritacarne referendario: consueti avvicendamenti sono diventati “rimosso perché non allineato”.
Nulla che ci allontano dalle vecchie dichiarazioni della vecchia politica, e stavolta il classico “lottizzazione” è stato lessicalmente surclassato dal “pro o contro al referendum”.
Ed anche se il comitato per il NO non ha raggiunto le 500mila firme fermandosi a 200mila, questa non è una buona notizia per il premier: va letta infatti come debolezza della sostanza ma solo come divisione interna delle opposizioni a costruire un comitato comune.
Oggi Renzi sembra aver compreso che qualcosa nella comunicazione sino ad oggi manichea del “o con me o contro di me”, del “o con il progresso o gufi”, a prescindere ed a qualunque costo, rischiava di essere un boomerang.
Il tono cambia nella ultima E-News in un più morbido: questo il passaggio della newsletter 437
“In tanti mi hanno detto: “Matteo, questa non è la tua sfida, non personalizzarla”. Vero, questa è la sfida di milioni di persone che vogliono ridurre gli sprechi della politica, rendere più semplici le istituzioni, evitare enti inutili e mantenere tutte le garanzie di pesi e contrappesi già presenti nella nostra Costituzione. Un’Italia più semplice e più forte sarà possibile se i cittadini lo vorranno.
Dipende da ciascuno di noi, non da uno solo, dunque, ma da un popolo.”
Il cambiamento non è di poco conto, e sintatticamente punta quasi a costruire un diverso elettorato.
Il premier mira stavolta a presentare la riforma come “qualcosa di utile” all’Italia, al popolo italiano, ad una maggioranza di persone trasversale che – indipendentemente dalla propria soggettiva posizione politica – vuole un sistema legislativo più snello e moderno.
In questo senso anche il richiamo – anch’esso non di poco conto – a sottrarre dal dibattito referendario temi che le opposizioni vorrebbero strumentalmente trascinare dentro: legge elettorale, poteri del governo e nello specifico del premier.
Nella stessa e-news: “Il quesito infatti non riguarda la legge elettorale o i poteri del Governo, argomenti che non sono minimamente toccati dalla legge costituzionale, ma riguarda il numero dei politici, il tetto allo stipendio dei consiglieri regionali, il voto di fiducia, il Senato, il quorum per il referendum che viene abbassato, l’introduzione del referendum propositivo, l’abolizione degli enti inutili come il CNEL, le competenze delle Regioni.”
Non possiamo sapere se questo cambio di strategia sarà sufficiente e sufficientemente efficace a “cambiare verso” ad una comunicazione manichea, tossica, e spesso controproducente, che connotava un tono arrogante e spesso saccente.
Non possiamo prevedere se “gli altri” comprenderanno a loro volta che sarà necessario adeguare anche la loro risposta. Perché l’errore, stavolta, sarebbe continuare con quell’idea del “votate no per mandare a casa Renzi”.
Messaggio forte, chiaro, semplice, ma non sufficiente per mettere insieme “il massimo della coalizione possibile per il no”. Mentre palazzo Chigi pare aver chiaro che serve una drastica sterzata e inversione di tendenza per mettere insieme “il massimo della coalizione possibile per il si”.
Tra 60-70 giorni si voterà.
La campagna è lunga, ma quella vera dobbiamo ancora vederla.
Perché Trump potrebbe anche vincere
Viste con gli occhi occidentali, molto spesso le elezioni americane sono apparse come “dai risultati scontati”. Fu così per le elezioni di Nixon, con il primo mandato di Reagan, con l’elezione di Bush: tutti casi in cui avevamo l’impressione certa che a vincere invece sarebbero stati i democratici.
Corriamo lo stesso rischio oggi, nel non comprendere la politica americana, e ancor più nel non riuscire ad analizzare sino in fondo il fenomeno Trump.
Rischio di sbagliare che corrono anche molti network americani, forti di sondaggi che vedono in testa la Clinton di circa sette punti percentuali.
Intanto non dobbiamo dimenticare che Hillary Clinton – che avrebbe dovuto vincere a mani basse – ha superato Bernie Sanders grazie ai voti dei “maggiorenti” del partito: quei grandi elettori che votano “a prescindere” rispetto alle indicazioni dei propri stati di appartenenza, e nei quali il risultato è stato spesso sul filo di lana.
È bene ricordare innanzitutto che il sistema elettorale americano non prevede che vinca chi conquista più voti in assoluto, e nemmeno chi vince nel maggior numero di stati, ma chi vince il maggior numero di “voti presidenziali”, ovvero chi vince, anche solo di pochi voti, negli stati più popolosi.
Ohio, Florida, Texas, Georgia, Illinois, California, New York, Pennsylvania, Washington ad esempio contano tantissimo, e da soli teoricamente garantirebbero i 270 voti richiesti, mentre quasi tutti gli stati centrali pesano dai 3 ai 7 voti.
E non è un caso che Donald Trump – che queste elezioni le vuole vincere – ha adottato una strategia per vincere le primarie, riuscendo a gestire una campagna per lui difficile, ma nel contesto di un partito estremamente diviso.
Il GOP infatti – certo di vincere dopo otto anni democratici, e con ottimi segnali nelle elezioni di medio termine – è riuscito di fatto a sterilizzare le iniziative presidenziali di Obama a fine mandato, ridimensionando al massimo la capacità del presidente in carica di fare campagna elettorale con scelte amministrative forti, essendo privo della maggioranza sia alla Camera che in Senato.
Se il GOP avesse voluto sbarrare la porta a Trump sarebbe bastato un accordo forte tra Rubio e Cruz, che non solo avrebbe garantito a quel tandem un numero di delegati sufficiente, ma anche ricompattato il partito e il flusso dei finanziamenti.
Se tutto ciò non è avvenuto non è solo per problemi di leadership ma per un male più profondo dei repubblicani americani, incapaci di immaginare una vera politica alternativa per il nuovo millennio.
Intanto in politica estera, dopo i tanti danni – anche in patria – causati dalla politica “alla Bush”.
Poi in politica economica, dopo essere stati per decenni i difensori di quella classe manageriale ed imprenditoriale protagonista dell’ultima recessione globale, ma anche della macelleria sociale interna.
Come hanno dichiarato molti autorevoli sostenitori del GOP, questi politici si sono presentati più come politicanti, e mai il partito conservatore è stato percepito così tanto affarista e corrotto.
In questa logica la campagna di Trump è stata vincente soprattutto tra gli elettori medi del partito: un uomo che si è proposto come non-politico, fatto da sé e senza lobby dietro la sua campagna.
Come sempre in politica, che ciò sia vero o falso è poco rilevante se riesce ad essere efficace.
Adesso che però la campagna elettorale è cambiata, e si tratta di andare oltre i repubblicani, Trump non solo cambia strategia, ma cambia anche la sua squadra di comunicazione.
Trump è un imprenditore, e il suo team elettorale non è solo “una squadra politica” – come può essere per altri candidati, ma soprattutto una squadra fatta dei manager migliori per quel lavoro specifico in questo specifico momento, ovvero i “cento giorni” dal voto.
Sottovalutare questa scelta e relegarla ad una questione interna di un comitato elettorale significa sottovalutare uno degli aspetti più significativi di questa campagna elettorale che – comunque finisca – è destinata a trasformare la politica americana.
Tra gli errori che spesso commettiamo nel commentare ed analizzare queste elezioni c’è ad esempio il continuare a ritenere che dato che molti repubblicani non appoggiano Trump la Clinton avrà come alleata la frattura interna dei suoi avversari, significa non aver compreso che questa patologia è tipicamente democratica e non certo repubblicana, e che i candidati a governatore, a deputato, a senatore, ma anche a sindaco, a sceriffo, a giudice, nelle varie comunità, che si riconoscono nel Gop, non esiteranno ad accostare il proprio volto al candidato ufficiale del partito (semmai storcendo il naso nel privato di casa propria); questo si, forse come non farebbero alcuni democratici.
Trump oggi è in definitiva non solo un candidato repubblicano, ma anche il candidato di gran parte di quella popolazione moderata che attribuisce – a torto o a ragione – alla politica, tutta, una eccessiva vicinanza e connivenza con i protagonisti delle recessioni, dei fallimenti finanziari, delle bolle speculative.
Non perdona ai politici che tutti questi nomi, dopo poche apparizioni ai notiziari, non abbiano fatto anni di galera, e che vivano da pensionati d’oro con fortune al sole. E questo nonostante lo show di qualche processo-spettacolo.
La Clinton – anche qui, a torto o a ragione – non è certamente al di fuori di queste logiche bipartisan della politica americana, anzi.
Al fascino della prima donna presidente, della prima first lady presidente, del primo ex-presidente nelle vesti di first-man, manca ancora una spinta propulsiva forte in termini di progetto e programma politico tale che, dopo due mandati democratici a firma Obama, possa portare ancora il paese a scegliere i democratici, di cui certamente lei non è un volto nuovo, né può dichiararsi al di fuori di quelle logiche che i cittadini non sono più disposti a tollerare.
Che l’ex first lady piaccia di più ai media, che sia più politically correct, e che rientri maggiormente negli schemi tanto cari alla televisone-spettacolo, può costituire un vantaggio personale in termini di appoggio dei grandi network.
Di certo Trump è più inviso, meno gestibile e affidabile, più imprevedibile, e queste caratteristiche piacciono poco ai direttori delle news.
Inoltre la Clinton è più vicina ai grandi investitori pubblicitari dei network di Trump, ed anche questo non guasta nella politica spettacolo made in USA.
Ma tutto questo non deve far dimenticare che a votare sono i cittadini, e spesso i cittadini, anche quando comprano le merci pubblicizzate non simpatizzano affatto per i loro produttori.
Si, Trump potrebbe anche vincere.
E mai come questa volta tutto dipenderà dai manager della sua campagna.
In quali Stati si concentreranno, con quanta spinta – anche finanziaria – conteranno i voti presidenziali da conquistare strategicamente, oltre quelli che “verranno da sé”.
E mai come in queste elezioni conteranno anche le opinioni pubbliche estere, perché mai come questa volta i cittadini degli Stati Uniti si sentono un po’ meno al centro del mondo, e non è un caso che la “capacità di leadership” sia tornata determinante, dopo anni in cui appariva scontata.
I sette punti di vantaggio per la Clinton ci sono, questo può anche essere vero.
Ma va anche compreso dove, in quali stati, e quali saranno le strategie per consolidare o ribaltare questi numeri. E in cento giorni tutto è possibile.
ISIS e la strategia della guerra santa
Da sigla quasi sconosciuta, e relegata a costola di Al-Qaida, l’ISIS domina ormai la scena delle cronache non solo estere ma sempre più della cronaca di casa nostra. Le pagine di tutti i giornali del mondo sono “invase” – letteralmente – da notizie temi e immagini che sino a qualche mese fa erano prevalentemente diffuse attraverso il web, ponendo mille interrogativi e generando qualsiasi teoria complottista e retroscenista.
Nel mio ebook “Isis, la comunicazione globale del terrore” quello che ho analizzato e il “modello comunicativo”, ossia l’evoluzione del modo con cui i movimenti jihadisti e qaidisti avevano deciso di comunicare, la loro strategia di creazione del modulo-mito e gli obiettivi strategici di questa nuova forma comunicativa.
Per la prima volta infatti – salvo sporadici episodi marginali – la jihad era uscita dai confini territoriali e culturali di specifiche aree geopolitiche, e faceva proseliti in occidente, presso ragazzi occidentali: prendeva a piene mani da quelle esperienze e competenze comunicative per implementare e sviluppare maggiormente l’efficacia della sua strategia comunicativa.
La globalizzazione del terrore oggi ha il logo e il marchio dell’ISIS, e da pezzo primordiale della nuova forma della comunicazione globale dell’estremismo, che recluta in tutto il mondo, in tutte le fasce d’età ed in ogni lingua, e che diffonde il suo messaggio senza alcun limite e confine territoriale, senza fasce protette, senza distinzioni di sesso, razza, religione, colore, situazione, contesto, oggi compie un salto di qualità tutt’altro che indifferente.
Come ogni prodotto virale l’unica regola è che “ciò che viene dopo” dovrà essere “più bravo, più virale, più strutturato” per emergere, ma anche più crudo, più violento, più sanguinario e con ancora meno limiti, per emergere come “soggetto nuovo” per evitare che “per il pubblico” sia qualcosa di “vecchio e già visto”.
In questa logica va visto il “protagonismo terrorista” di questi ultimi mesi, a cavallo dell’estate e dei mesi di vacanza e di maggior turismo in occidente: cogliere il miglior momento possibile a livello comunicativo per generare ansia, terrore, indurre al cambiamento delle abitudini, gestire la vita e l’agenda dei cittadini (principalmente europei), dominare da protagonisti le pagine di cronaca.
Irrilevante che ciò riguardi il Bangladesh (basta colpire cittadini europei), Nizza durante una festa nazionale o un paese della provincia in un giorno qualunque in un momento qualsiasi della normale vita della comunità locale.
Isis – macabramente – si connota sempre più come un fenomeno mediatico, capace di polarizzare l’attenzione, la cronaca, i social network, la politica, collegandosi a qualsiasi momento mediatico.
Smette di essere – mediaticaente parlando – un fenomeno bellico, geolocalizzato, legato alla politica estera o ai temi della cronaca internazionale.
Interessante a tal proposito la critica, e in parte autocritica, del Le Monde, all’indomani dell’attaco di Saint-Entienne-du-Rouvray, nel quadro della più ampia – e seria discussione – se il pubblicare nomi, foto e dettagli sulle identità dei terroristi possa alimentare le più deliranti teorie del complotto, o se “anonimizzare” il terrorismo possa invece essere utile a ridurre il desiderio di emulazione lasciando i terroristi nell’oblio.
Un dibattito non senza fondamenti seri nel nuovo territorio del terrore globalizzato.
Da un lato il diritto di cronaca ed informazione, dall’altro la presa d’atto di un fenomeno globale emulativo.
L’Isis è sempre più solo un marchio, che compie essenzialmente due azioni coordinate: invitare e stimolare l’azione kamikaze, quanto più cruenta possibile, e ovunque, e rivendicare qualsiasi azione terroristica, anche se non direttamente collegata.
Un binomio relativamente economico e che sfrutta consapevolmente e scientificamente le nuove forme di comunicazione di un mondo mediaticamente globalizzato, in cui la cultura dello scandalo e della cronaca violenta diviene focalizzatore di pubblico e share.
Un tema su cui la stampa internazionale dovrebbe riflettere con maggiore consapevolezza, uscendo da semplice ruolo di “riportatrice di fatti di cronaca” e comprendendo che invece può essere soggetto attivo della diffusione di un messaggio e da stimolo – attraverso la spettacolarizzazione – di atti di emulazione.
L’estremizzazione del messaggio fondamentalista e jihadista non è efficace solo se “tu scegli di
combattere da quella parte”, ma raggiunge un risultato anche se tu semplicemente scegli di
combattere quella guerra, perché in fin dei conti raggiunge l’obiettivo di farti schierare in prima
persona sul campo, che significa legittimazione come avversario, unico e definitivo. Che poi è
l’obiettivo politico globale dell’ISIS.
Oggi appare chiaro che lo Stato Islamico, decisamente in difficoltà sui campi di battaglia e nelle aree geografiche in cui combatte militarmente, punta ad una sfida mediatica totale.
L’obiettivo è la “guerra totale” di religione. Identificare se stesso come “il vero Islam” e tutti quelli che non sono con l’Isis sono “infedeli che combattono una guerra religiosa”.
Riuscire in questo obiettivo sarebbe un suicidio politico, culturale e civile dell’intero occidente.
Ma in questa direzione vanno non solo “il messaggio” diretto dell’Isis, ma anche e soprattutto la simbolica degli attacchi, come l’uccisione in chiesa di un sacerdote.
E per questo l’occidente non può cadere nella provocazione di criminalizzare l’islam in quanto tale.
Non può cedere al facile manicheismo di chi vorrebbe una divisione del mondo e delle persone.
Sarebbe la vittoria dell’Isis che potrebbe concretizzare se stesso come “islam che difende gli islamici” contro “un mondo di infedeli che vogliono una guerra santa contro l’islam”.
In questo senso sono tutt’altro che simboliche le prese di posizione di molti imam, presenti a cerimonie inter-religiose, o come la presa di posizione della comunità islamica francese che ha rifiutato la sepoltura musulmana ai terroristi.
Un modo di non cadere nell’equivoco crociato, e di bilanciare il messaggio jihadista sul suo stesso terreno. Come a dire “se qualcuno vi promette che con il terrorismo avrete il paradiso, sappiate che non avrete nemmeno una sepoltura religiosa”.
E questo messaggio, e questa posizione forte, a ben vedere, possono essere davvero l’arma più potente contro questo nuovo terrorismo.
Krusciov contro Stalin nel 1956
Il 25 febbraio 1956, Nikita Krusciov, Segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, nel corso di una sessione a porte chiuse dei delegati al XX Congresso del Partito, nel palazzo del Cremlino a Mosca, tenne un lungo rapporto in cui demolì la figura politica di Stalin.
Fu l’inizio ad un processo, comunemente definito “destalinizzazione” in virtù del quale vi fu la definitiva caduta del regime totalitario e una parziale liberalizzazione della vita politica e culturale dell’URSS.
Per alcune settimane questo rapporto rimase segreto. Dopo qualche tempo se ne ebbero varie indiscrezioni da fonti diverse, finché il 4 giugno 1956, a cura del Dipartimento di Stato degli USA, fu reso noto un testo che risultò però privo di 32 frasi.
Il 9 giugno un’agenzia giornalistica italiana rese di pubblicò le frasi mancanti dal testo diramato dal Dipartimento di Stato. Tali frasi vennero rese note sulla base di notizie provenienti da ambienti cecoslovacchi, potendo così ricostruire nella sua interezza e autenticità il documento fondamentale del nuovo corso sovietico.
Questa è l’apertura e la parte centrale del rapporto, specificamente rivolta all’operato di Stalin nel corso della seconda guerra mondiale.
Chruščëv ricevette solo circa due anni di educazione elementare, e probabilmente imparò a leggere verso i trent’anni. Lavorò come installatore di tubi in varie fabbriche e miniere. Durante la prima guerra mondiale, s’impegnò in attività sindacali, e dopo la rivoluzione russa del 1917 combatté nell’Armata rossa. Divenne membro del partito nel 1918 e lavorò in varie posizioni amministrative
Nel 1931 passò per le segreterie de comitati distrettuali di vari quartieri di Mosca, mentre nel 1932 venne eletto secondo segretario del comitato cittadino di Mosca. Nel 1934 divenne Primo Segretario moscovita del partito Comunista dell’Unione Sovietica, e secondo segretario del comitato regionale di Mosca. Dal 1934 Chruščëv fu membro effettivo del comitato centrale del partito Comunista dell’Unione Sovietica. Nel gennaio del 1938 fu nominato come “facente funzione” di primo segretario del comitato centrale del Partito Comunista Ucraino, in sostituzione dei precedenti membri falcidiati dalle persecuzioni staliniane del 1937-1938.
Venne invece effettivamente eletto a tale carica nel giugno dello stesso anno. Fu eletto membro candidato del Politburo nel 1938, contestualmente all’elezione nel Presidium (comitato esecutivo) del neo-eletto soviet supremo dell’URSS, alla prima elezione dopo la nuova costituzione del 1936.
Dopo la morte di Stalin, avvenuta nel marzo 1953, si scatenò la lotta per la successione all’interno del partito. Inizialmente sembrò predominante la posizione di Lavrentij Pavlovič Berija, ministro degli Interni e capo della polizia segreta. Ad ogni modo,Georgij Malenkov, Lazar Kaganovič, Vjačeslav Molotov, Nikolai Bulganin e altri appoggiarono Chruščëv e fecero rimuovere Berija dal potere. Berija fu imprigionato in attesa dell’esecuzione che avvenne poi in dicembre.
La leadership di Chruščëv fu cruciale per l’URSS. Egli stupì i delegati del XX Congresso del PCUS il 25 febbraio 1956 col suo famoso “discorso segreto” in cui denunciava il culto della personalità di Stalin e i crimini commessi durante la Grande Purga. Per questo Chruščëv fu criticato dai membri più conservatori del partito, che cercarono di spodestarlo nel 1957. Nonostante ciò Chruščëv riuscì a mantenere la sua posizione e ad allontanare i conservatori dal potere. Il 27 marzo 1958 Chruščëv rimpiazzò Bulganin come primo ministro dell’Unione Sovietica e si stabilì come unico capo dello Stato e del partito. Chruščëv promosse riforme del sistema sovietico e una maggiore produzione dell’industria pesante.
Nel 1959 Richard Nixon, allora Vice Presidente degli Stati Uniti, trascorse le sue vacanze in Unione Sovietica, inviato dal presidente Eisenhower per inaugurare l’Esposizione Nazionale Americana a Mosca. Durante tale visita, tra l’altro, il 24 luglio Nixon e Chruščëv discussero pubblicamente i meriti dei rispettivi sistemi economici, capitalismo ed economia pianificata, in un improvvisato confronto passato alla storia come “dibattito in cucina”, perché ebbe luogo principalmente nella cucina di una casa prefabbricata americana presentata all’esposizione. Chruščëv poi ricambiò la visita recandosi a settembre, per tredici giorni, negli Stati Uniti. In tale occasione, sicuro che una coesistenza pacifica tra le due potenze avrebbe portato alla lunga alla vittoria, senza traumi, del sistema comunista, ebbe modo di dire alla televisione americana: «I vostri nipoti vivranno sotto un regime comunista!». La visione da parte di Chruščëv degli Stati Uniti come rivale anziché come nemico “diabolico” causò l’allontanamento della Cina di Mao Zedong: l’URSS e la Repubblica Popolare Cinese arrivarono a una rottura diplomatica nel 1960.
Chruščëv si trovò in grandi difficoltà all’interno del suo partito dopo l’insuccesso nella gestione della crisi di Cuba, in seguito alla quale la flotta russa che trasportava missili per il governo filo-sovietico di Cuba dovette fare un rapido dietro-front di fronte al blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La sua caduta fu apparentemente il risultato di una cospirazione da parte dei capi del partito, irritati dalla sua politica estera che mise in imbarazzo il partito e l’URSS stessa nello scenario internazionale. Il PCUS accusò Chruščëv di aver commesso errori politici durante la crisi dei missili di Cuba nel 1962 e di aver organizzato male l’economia sovietica, soprattutto nel settore agricolo.
I cospiratori, guidati da Leonid Brežnev, Aleksandr Šelepin e dal capo del KGB Vladimir Semičastny, portarono alla deposizione di Chruščёv nell’ottobre 1964, quando si trovava a Pitsunda. I cospiratori convocarono un consiglio speciale del Presidium del Comitato Centrale e quando Chruščëv arrivò, il 13 ottobre, il Consiglio votò a favore delle sue dimissioni da ogni incarico nel partito e nel governo. Il 15 ottobre 1964 il Presidio del Soviet Supremo accettò le dimissioni di Chruščëv da premier dell’Unione Sovietica.
In seguito alle sue dimissioni, Chruščëv trascorse il resto della sua vita come pensionato a Mosca. Rimase nel comitato centrale fino al 1966. Per il resto della sua vita fu guardato a vista dal KGB, ma non si dedicò ad altro che alle sue memorie e ad altri affari di minore importanza riguardanti l’Occidente. Morì a Mosca l’11 settembre 1971. Gli furono negati i funerali di stato e la sepoltura dentro al Cremlino.
Le vicende di Chruščëv rappresentano la perfetta trama di quella che fu la guerra fredda, con capri espiatori, grandi poteri di apparato che muovono le fila dietro le quinte, pronti al “colpo di stato” interno.
La sua destituzione è in effetti molto simile a quella che sarà la fine politica di Gorbaciov nel 1991.
Messo a capi dell’URSS come un “piccolo burocrate” facilmente maneggiabile, con l’acume di chi ha costruito una carriera tutta in salita e tutta dall’interno Chruščëv ha gestito il difficile passaggio interno della morte di Stalin, e i rischi che correva l’Unione Sovietica sotto tutti i fronti: sostanziale povertà con tutti i rischi sociali possibili, fragilità della leadership internazionale mancando altre figure carismatiche dopo le purghe e la morte di Stalin, fragilità dell’equilibrio interno per la lotta di potere per la successione, incombenza del fronte occidentale, con i rischi di una terza guerra mondiale, stavolta nucleare.
E gestì questo potere mostrando una consapevolezza totale dei sistemi di comunicazione di massa.
Lo fece prima demolendo il culto della personalità di Stalin, e in due modi.
Una “relazione segreta”, per dare l’immagine di tutelare il partito, l’Unione Sovietica, e per far passare l’idea apparente che fosse una questione interna.
Una relazione resa pubblica per via indiretta per rivendicare una forza personale capace anche di sfidare l’immagine stessa di Stalin.
È proprio l’idea della necessità di “abbattere l’icona” che diventa momento innovativo e rivoluzionario della politica di Chruščëv, che aveva compreso perfettamente come l’uso iconoclastico nell’accostamento con Lenin e Marx, nell’uso della finzione cinematografica e cinegiornalistica, era il primo elemento da abbattere per creare nuove leadership nell’era della comunicazione di massa.
In questo senso vanno inquadrati e messi insieme l’atto di accusa a Stalin, il dibattito in cucina con Nixon, la visita negli Stati Uniti, la scarpa sbattuta sul tavolo alle Nazioni Unite.
Compagni,
Nel rapporto del Comitato Centrale del Partito al XX Congresso, in numerosi discorsi dei delegati al Congresso stesso ed anche prima, durante la sessione plenaria del CC-PCUS, si è parlato molto del culto della personalità e delle sue dannose conseguenze.
Dopo la morte di Stalin il Comitato Centrale del Partito cominciò ad attuare una politica intesa a spiegare. concisamente e coerentemente che non è lecito ed è estraneo allo spirito del marxismo-leninismo esaltare una sola persona, e trasformarla in un superuomo in possesso di doti sovrane naturali simili a quelle di un Dio.
Un simile uomo è ritenuto in grado di sapere tutto, vedere tutto, pensare per tutti, fare qualsiasi cosa ed essere infallibile nella propria condotta.
Un simile culto per un uomo, e precisamente per Stalin, è stato diffuso tra di noi per molti anni.
Lo scopo del presente rapporto non è una valutazione esauriente e definitiva della vita di Stalin. Sui meriti di Stalin è stato già scritto durante la sua vita un numero sufficiente di libri, di opuscoli e di saggi. La funzione di Stalin nella preparazione e nell’esecuzione della rivoluzione socialista, nella guerra civile e nella lotta per l’edificazione del socialismo nel nostro paese è universalmente nota e tutti la conoscono bene. Attualmente noi ci preoccupiamo di una questione che ha un’immensa importanza per il nostro partito oggi e per il futuro. Ci preoccupiamo cioè di come si sia venuto gradualmente sviluppando il culto della persona di Stalin, quel culto che in un certo dato momento è divenuto la fonte di tutta una serie di gravissime perversioni dei principi del partito, della democrazia del partito e della legalità rivoluzionaria. E poiché non tutti si rendono ancora pienamente conto delle conseguenze pratiche che derivano dal culto della personalità, del grande danno causato dalla violazione del principio della direzione collegiale del partito e in seguito all’accumularsi di un immenso e quasi illimitato potere nelle mani di una sola persona, il Comitato Centrale del partito ritiene assolutamente necessario portare a conoscenza del XX Congresso del PCUS il materiale relativo a tale questione.
La somma di poteri accumulatasi nelle mani di una sola, persona — Stalin — determinò gravi conseguenze durante la grande guerra patriottica.
Se ripensiamo a gran parte dei nostri romanzi, dei nostri films e dei nostri ” studi scientifici ” di carattere storico, il ruolo da essi assegnato a Stalin nella guerra patriottica risulta completamente inattendibile. Stalin aveva previsto tutto. L’esercito sovietico, sulla base di un piano strategico
articolato da Stalin molto tempo prima, impiegò la tattica della cosiddetta “ difesa attiva “, ossia la tattica che — come sappiamo — consentì ai tedeschi di arrivare a Mosca e a Stalingrado. Impiegando questa tattica — si afferma — l’esercito sovietico, in virtù unicamente del genio di Stalin, poté passare all’offensiva e sconfiggere il nemico. L’epica vittoria ottenuta grazie alla potenza armata del paese dei Soviet, grazie all’eroismo del nostro popolo, viene descritta, in questo tipo di romanzi, di film e di ” studi scientifici “, come dovuta unicamente al genio di stratega di Stalin.
Dobbiamo esaminare con la massima attenzione questo argomento, perché esso ha una estrema importanza, non soltanto dal punto di vista storico, ma soprattutto da quello politico, educativo e pratico. Quali sono i fatti relativi a questo problema? Prima del conflitto, la nostra stampa e la nostra attività politico – educativa erano caratterizzate da un tono di vanteria: se un nemico violerà i confini dell’amata terra dei Soviet, allora ad ogni colpo dell’avversario noi risponderemo con tre colpi, combatteremo il nemico sul suo territorio nazionale e vinceremo senza neanche subire gravi perdite. Sennonché, queste affermazioni di principio non erano basate, sotto ogni rispetto, su fatti concreti, i quali soltanto avrebbero potuto effettivamente garantire l’inviolabilità delle nostre frontiere.
Durante e dopo la guerra, Stalin sostenne la tesi che la tragedia vissuta dalla nostra patria, fu il risultato dell’attacco ” inatteso ” dei tedeschi contro l’Unione Sovietica. Senonchè, compagni, ciò è assolutamente falso. Appena conquistato il potere in Germania, Hitler si era imposto il compito di liquidare il comunismo. I fascisti lo dichiaravano apertamente, e non facevano mistero dei loro disegni. Per il conseguimento di questo loro fine aggressivo, diedero vita ad ogni sorta di patti e di blocchi, come il famoso asse Berlino – Roma – Tokio. Molti fatti del periodo pre-bellico stavano a dimostrare chiaramente che Hitler si preparava ad iniziare una guerra contro lo Stato sovietico e che aveva ammassato grandi concentramenti di truppe e di unità corazzate presso i confini dell’URSS.
Documenti che sono stati testé pubblicati rivelano che il 3 aprile 1941 Churchill, tramite l’Ambasciatore britannico a Mosca, Cripps, avvertì personalmente Stalin del fatto che i tedeschi avevano ripreso a schierare in ordine di combattimento le loro unità, nell’intento di attaccare l’Unione Sovietica. E’ di per sé evidente che Churchill non agiva così soltanto per spirito di amicizia verso la nazione sovietica. Egli perseguiva i suoi fini imperialistici: coinvolgere la Germania e l’URSS in una guerra sanguinosa, e rafforzare in tal modo la posizione dell’impero britannico,a nostre spese, come in modo subdolo, anche gli attuali dirigenti britannici cercano di fare. Proprio lo stesso Churchill ebbe ad affermare nei suoi scritti che egli intendeva ” avvertire Stalin e richiamare la sua attenzione sul pericolo che lo minacciava “. Churchill ribadì questo avvertimento a più riprese, nei suoi messaggi del 18 aprile e dei giorni seguenti. Tuttavia, Stalin non tenne alcun conto di questi avvertimenti. Non solo, ma ordinò che non si accordasse alcun credito a informazioni di questo genere, allo scopo di non provocare l’inizio di operazioni militari.
Va precisato che tali informazioni riguardanti la minaccia di una invasione armata del territorio sovietico da parte tedesca venivano anche dalle nostre fonti diplomatiche e militari; sennonché, dato che il capo supremo era prevenuto contro tali informazioni, le notizie venivano trasmesse con timore e valutate con riserva.
Così, per esempio, una comunicazione inviata il 6 maggio 1941 dall’Addetto militare sovietico a Berlino, cap. Vorontsov, diceva: ” Il cittadino sovietico Bozer… ha informato il vice addetto navale che, secondo una dichiarazione fatta da un ufficiale tedesco appartenente al quartier generale di Hitler, la Germania si prepara ad invadere l’URSS il 14 maggio attraverso la Finlandia, i Paesi Baltici e la Lettonia. Contemporaneamente, Mosca e Leningrado saranno sottoposte a bombardamenti massicci, e truppe paracadutiste saranno lanciate nella città di confine… “.
Nella sua relazione del 22 maggio 1941, poi, il vice addetto militare a Berlino, Khlopov, comunicava che ” … L’attacco dell’esercito tedesco è presumibilmente fissato per il 15 giugno, ma non è da escludere che possa avere inizio ai primi di giugno… ”.
Un cablogramma della nostra Ambasciata di Londra in data 18 giugno 1941 diceva: “Cripps è ormai profondamente convinto dell’inevitabilità di un conflitto armato fra la Germania e l’URSS che avrà inizio non più tardi della metà di giugno. Secondo Cripps, i tedeschi hanno attualmente concentrato lungo i confini sovietici 147 divisioni (comprese le unità aeree e quelle addette ai servizi logistici)”.
Nonostante questi avvertimenti di particolare gravità, non furono compiuti i passi necessari a preparare adeguatamente il paese alla difesa e ad impedire che venisse colto alla sprovvista.
Avevamo il tempo e la capacità di fare questi preparativi? Si, avremmo avuto tempo e capacità. Lo sviluppo della nostra industria era già tale che avrebbe potuto fornire all’esercito sovietico tutto ciò di cui aveva bisogno. E ciò è provato dal fatto che, sebbene durante la guerra avessimo perduto quasi la metà delle nostre industrie e alcune regioni particolarmente importanti per la produzione alimentare e industriale (in conseguenza dell’occupazione nemica dell’Ucraina, del Caucaso settentrionale e di altre zone occidentali del paese), la nazione sovietica poté tuttavia organizzare la produzione degli equipaggiamenti militari nelle regioni orientali del paese, installandovi le attrezzature trasportate dalle zone industriali dell’ovest, e poté altresì fornire alle nostre forze armate tutto quelle che era loro necessario per distruggere il nemico.
Se la nostra industria fosse stata mobilitata adeguatamente e tempestivamente per assicurare all’esercito i materiali necessari, le nostre perdite del periodo bellico sarebbero state decisamente inferiori. Questa mobilitazione, peraltro, non ebbe un inizio tempestivo. E già nei primi giorni di guerra risultò evidente che l’armamento del nostro esercito era scadente e che non disponevamo di artiglierie, carri armati e aeroplani sufficienti per respingere il nemico.
La scienza e la tecnologia sovietica avevano prodotto, prima della guerra, eccellenti tipi di carri armati e di pezzi di artiglieria. Ma la loro produzione in massa non era stata organizzata, e in definitiva noi incominciammo a modernizzare il nostro equipaggiamento militare soltanto in tempo di guerra. Di conseguenza, al momento dell’invasione nemica del paese dei Soviet, non disponevamo di quantitativi sufficienti né dei vecchi armamenti, né dei nuovi macchinari che si era progettato di impiegare in detta produzione. La situazione per quanto riguardava l’artiglieria antiaerea era particolarmente grave; non avevamo organizzato la produzione di munizioni anticarro. Molte regioni dotate di fortificazioni si erano rivelate indifendibili non appena attaccate, perché le vecchie armi erano state ritirate, e le nuove non erano ancora a disposizione dei difensori.
Ciò riguardava, purtroppo, non soltanto i carri armati, le artiglierie e gli aeroplani. Allo scoppio della guerra non avevamo neppure un numero sufficiente di fucili per armare il personale mobilitato. Ricordo che in quei giorni telefonai da Kiev al compagno Malenkov e gli dissi: ” La gente si presenta volontaria per il nuovo esercito, e chiede armi. Dovete mandarci armi “. Ma Malenkov mi rispose :” Non possiamo mandarvi armi. Stiamo mandando tutti i nostri fucili a Leningrado e voi dovrete armarvi come potete “.
(Reazioni in aula).
Questa dunque era la situazione degli armamenti.
A questo riguardo, non possiamo dimenticare, per esempio, il fatto che ora vi dirò. Poco tempo prima dell’invasione dell’Unione Sovietica da parte dell’esercito hitleriano, Korponos. che era capo del distretto militare speciale di Kiev (egli morì in seguito al fronte), scrisse a Stalin che gli eserciti tedeschi erano sul fiume Bug. che si preparavano per un attacco e che in futuro assai vicino avrebbero probabilmente iniziato l’offensiva. A questo proposito, Korponos proponeva l’organizzazione di una forte difesa, e suggeriva che 300.000 persone venissero evacuate dalle zone di confine e che ivi fossero apprestati parecchi strumenti di resistenza: dighe anticarro, trincee per i soldati, ecc.
Mosca rispose a questo suggerimento con l’affermazione che ciò avrebbe costituito una provocazione, che nessun preparativo a carattere difensivo doveva essere intrapreso alle frontiere, e che ai tedeschi non doveva essere offerto alcun pretesto per intraprendere un’azione militare contro di noi. Pertanto, le nostre frontiere non erano sufficientemente munite, per respingere il nemico.
Quando gli eserciti fascisti invasero effettivamente il territorio sovietico, e le operazioni militari ebbero inizio, Mosca impartì l’ordine di non rispondere al fuoco dei tedeschi. Perché? Perché Stalin, nonostante l’evidenza dei fatti, riteneva che la guerra non era ancora cominciata, che si trattava soltanto di un atto di provocazione da parte di alcuni reparti indisciplinati dell’esercito tedesco e che una nostra reazione avrebbe potuto servire come pretesto ai tedeschi per iniziare la guerra.
Il fatto che ora vi dirò è anch’esso noto. All’epoca dell’invasione del territorio dell’Unione Sovietica da parte dell’esercito hitleriano, un « compagno » tedesco attraversò la nostra frontiera e disse che l’armata nazista aveva ricevuto l’ordine di iniziare l’offensiva contro L’URSS nella notte del 22 giugno alle ore 3. Stalin fu informato di ciò immediatamente, ma anche questo avvertimento restò ignorato. Come vedete, tutto restava ignorato; gli avvertimenti di taluni capi militari, le dichiarazioni di disertori dell’esercito nemico, e perfino l’apertura delle ostilità da parte del nemico. Era forse una prova di responsabilità questa che veniva fornita dal
capo del partito e dello Stato in un momento di così grande importanza storica?
Quali furono i risultati di questo atteggiamento di indifferenza, di questo disprezzo per fatti evidenti? Ne risultò che fin dalle prime ore e dai primi giorni il nemico aveva distrutto nelle regioni di frontiera gran parte della nostra aeronautica, dell’artiglieria e di altre attrezzature militari, annientato gran parte dei nostri quadri militari e disorganizzato i nostri comandi. Non potemmo quindi impedire al nemico di avanzare in profondità nel paese .
Conseguenze molto penose, specialmente per quanto riguarda l’inizio della guerra, furono il risultato dell’eliminazione di molti comandanti militari e lavoratori politici compiuta da Stalin nel periodo 1937-1941, a causa dei sospetti da lui nutriti e attraverso calunniose accuse. Durante questi anni vennero esercitate repressioni nei confronti di alcuni settori dei quadri militari, partendo letteralmente dal livello dei comandanti di compagnia e battaglione per giungere ai comandi più elevati; durante questo periodo il quadro dei comandanti che avevano acquistato tanta esperienza militare in Spagna e nell’Estremo Oriente fu quasi completamente distrutto.
La direttiva delle repressioni su vasta scala negli ambienti militari minò anche la disciplina militare in quanto per molti anni si insegnò ai sottufficiali di ogni grado e anche ai soldati, nelle cellule del Partito e dei Konsomol, a ” smascherare ” i superiori se nemici nascosti.
(Movimenti nell’aula).
E’ naturale che ciò esercitasse, nel primo periodo della guerra, un’influenza negativa sull’efficienza della disciplina militare. Prima della guerra, come ben sapete, noi possedevamo degli eccellenti quadri militari che erano, senza possibilità di dubbio, fedeli al partito e alla patria. Basterà dire che quelli che riuscirono a sopravvivere, nonostante le tremende torture loro inflitte nelle prigioni, si sono dimostrati fin dai primi giorni della guerra veri patrioti ed hanno combattuto eroicamente per la gloria della patria; penso a camerati come Rokossovsky, che, come ben sapete, era stato imprigionato, come Gorbatov, Martskov, oggi delegato al nostro congresso, Podlas, comandante di prim’ordine che perì al fronte, e molti altri. Molti di essi però perirono in campi di concentramento e in prigione, e l’esercito non li vide nelle sue file.
Tutto ciò provocò la situazione esistente al principio della guerra, così grave di minacce per la patria.
Sarebbe un errore dimenticare che dopo i primi gravi disastri e dopo le disfatte al fronte Stalin pensò che fosse giunta la fine. In uno dei discorsi tenuti in quei giorni egli disse: ” Abbiamo perduto per sempre tutto quello che Lenin aveva creato “. Successivamente, per un lungo periodo, Stalin non diresse più operazioni militari e cessò da qualsiasi attività. Egli riprese una direzione attiva solo quando alcuni membri del Politburo si recarono da lui per dirgli che era necessario prendere alcune misure immediate per migliorare la situazione sul fronte.
Il minaccioso pericolo che sovrastò la patria nel primo periodo della guerra fu quindi dovuto in gran parte agli errati metodi direttivi esercitati da Stalin nei confronti del paese e del partito.
Non parliamo, comunque, soltanto di quel momento in cui ebbe inizio la guerra e che provocò una grave disgregazione nell’esercito e gravi perdite al paese. Anche dopo che la guerra era già incominciata, il nervosismo e l’isterismo dimostrato da Stalin nell’interferire nelle operazioni militari causò gravi danni al nostro esercito.
Stalin era ben lungi dal comprendere la vera situazione che si era creata sul fronte e ciò era naturale perché, durante l’intera guerra patriottica, egli non visitò mai un settore del fronte o una città liberata, se si eccettua una breve passeggiata in macchina sull’autostrada Mozhaisk, in un periodo in cui la situazione sul fronte si era stabilizzata. A questo episodio accidentale furono dedicate molte opere letterarie piene di fantastici racconti di ogni genere e un numero infinito di quadri. Contemporaneamente, Stalin interferiva nelle operazioni militari e diramava ordini che non tenevano affatto conto della vera situazione su un determinato settore del fronte e che non solo non potevano migliorarla ma provocavano enormi perdite umane .
Mi permetterò, a tale proposito, di ricordare un fatto caratteristico che dimostra come Stalin dirigesse le operazioni sul fronte. Partecipa al nostro Congresso il Maresciallo Bagramyan che, nella sua qualità di ex capo delle operazioni al Quartiere Generale del fronte sud-occidentale, potrà confermare quanto sto per dirvi.
Essendosi nel 1942 creata una situazione eccezionalmente grave per il nostro esercito nella regione di Kharkov, avevamo opportunamente deciso di rinunciare ad un’operazione che si proponeva come obiettivo l’accerchiamento di Kharkov, in quanto la situazione esistente in quel momento minacciava per il nostro esercito conseguenze fatali qualora l’operazione fosse stata proseguita.
Comunicammo ciò a Stalin, precisando che la situazione richiedeva dei mutamenti nei piani operativi onde impedire al nemico di eliminare un importante settore del nostro esercito. Contrariamente al buonsenso, Stalin respinse il nostro suggerimento e ordinò che fosse eseguita l’operazione per l’accerchiamento di Kharkov, nonostante molti gruppi dell’esercito fossero in quel momento essi stessi minacciati di accerchiamento e quindi di eliminazione.
Telefonai a Vasilevsky e gli chiesi: ” Alexander Mikhailovish, prendi una carta (Vasilevsky è oggi presente) e spiega al compagno Stalin la situazione che si è venuta creando “. Bisogna ricordare che Stalin preparava le operazioni su un mappamondo.
(Animazione nell’aula).
Sì, compagni, egli si serviva di un mappamondo e su di esso segnava la linea del fronte. Dissi allora al compagno Vasilevsky: “Spiegagli la situazione sulla carta; data l’attuale situazione non possiamo attuare l’operazione progettata. La decisione già presa deve essere modificata per il bene della patria”.
Vasilevsky rispose che Stalin aveva già studiato il problema e che non intendeva rivederlo per parlargli della cosa in quanto questi non voleva ascoltare argomenti in proposito.
Dopo aver parlato con Vasilevskv, telefonai a Stalin nella sua villa; Stalin però non rispose e venne al telefono Malenkov. Dissi al compagno Malenkov che chiamavo dal fronte e che volevo parlare personalmente con Stalin. Stalin fece dire da Malenkov che dovevo parlare con quest’ultimo. Ribattei per la seconda volta che desideravo informare personalmente Stalin della grave situazione che si era andata creando sul fronte; Stalin però non ritenne opportuno sollevare il microfono e confermò che dovevo parlare con lui attraverso Malenkov, per quanto distasse dall’apparecchio solo pochi passi.
Dopo avere “ascoltato” in tal modo il nostro appello, Stalin disse: “Tutto deve restare immutato!”.
Quale fu il risultato di questa decisione? Quanto di peggio si potesse prevedere. I tedeschi circondarono i nostri raggruppamenti militari e perdemmo quindi centinaia di migliaia di soldati. Questo fu il ” genio ” militare di Stalin e questo il prezzo che tale ” genio ” ci costò.
(Movimenti nell’aula).
Un giorno, dopo questo, durante una riunione di Stalin con i membri del Politburo, Anastas Ivanovich Mikoyan ebbe a dire che Krusciov aveva ragione quando telefonò a proposito della situazione di Kharkov e che era un peccato che i suoi suggerimenti non fossero stati accettati.
Avreste dovuto vedere come si infurio Stalin! Come si poteva ammettere che Lui, Stalin, avesse avuto torto! Egli era dopotutto un ” genio” ed un ” genio ” non può che aver ragione! Tutti possono sbagliare, ma Stalin riteneva di non aver mai sbagliato e di aver avuto sempre ragione. Egli non ammise mai con alcuno di avere errato, né poco né molto, nonostante avesse commesso non pochi errori sia nel campo teorico che in quello pratico. Dopo il Congresso dovremo probabilmente riesaminare numerose operazioni militari del tempo di guerra e presentarle nella giusta luce.
La tattica nella quale Stalin insisteva, ignorando i rudimenti della strategia bellica, ci costò molto spargimento di sangue, fino a quando non riuscimmo ad arrestare il nemico e a passare all’offensiva.
I militari sanno che già verso la fine del 1941, invece di svolgere vaste manovre atte ad accerchiare il nemico onde colpirlo alle spalle, Stalin insisteva sugli attacchi frontali e la conquista successiva di villaggi. Ciò ci costò enormi perdite fino a quando i nostri generali, sulle cui spalle ricadeva tutto il peso dello svolgimento della guerra, non riuscirono a rovesciare la situazione e a passare a operazioni più flessibili, le quali provocarono immediatamente sul fronte importanti mutamenti in nostre favore.
Ancor più deprecabile fu il fatto che, dopo la grande vittoria sul nemico conquistata a così caro prezzo, Stalin cominciò a diffamare molti dei comandanti che tanto avevano contribuito alla vittoria sul nemico, poiché egli non ammetteva la possibilità che servizi resi sul fronte potessero essere attribuiti se non a lui.
Stalin era profondamente interessato alla valutazione del compagno Zhukov quale capo militare e mi chiedeva spesso cosa pensassi di lui. Io gli dissi allora: ” Conosco Zhukov da lungo tempo e lo ritengo un bravo generale e un buon capo militare”.
Dopo la guerra Stalin cominciò a raccontare un mondo di sciocchezze su Zhukov dicendo tra l’altro: ” Voi lodate Zhukov, ma egli non lo merita. Si dice che prima di ogni azione sul fronte Zhukov avesse l’abitudine di prendere una manciata di terra, annusarla e dichiarare: ” Possiamo dare inizio all’attacco “, o viceversa, ” il piano operativo stabilito non può essere attuato “. Io dichiarai allora: ” Compagno Stalin non so chi abbia inventato questa storia ma essa non risponde a verità “.
È possibile che Stalin stesso abbia inventato questa storia allo scopo di minimizzare la parte svolta dal maresciallo Zhukov ed i suoi talenti militari.
In questo campo Stalin invece cercava molto energicamente di rendersi popolare come un grande capo e in varie occasioni cercò di inculcare nel popolo l’idea che tutte le vittorie conquistate dall’Unione Sovietica durante la grande guerra patriottica erano dovute al coraggio, all’iniziativa audace e al genio di Stalin e non di altri. Al pari di Kryushkov (il famoso cosacco che compì contemporaneamente a sette persone lo stesso abito).
(Animazione nell’aula).
Sempre a questo proposito, prendiamo ad esempio, i nostri films storici e militari ed alcune opere letterarie; essi ci provocano la nausea in quanto il loro vero obiettivo è la diffusione di un solo tema: ” l’elogio di Stalin come genio militare “. Pensiamo al film ” La caduta di Berlino “.
In esso il protagonista è soltanto Stalin: egli emana ordini in una sala in cui le molte sedie sono vuote ed un uomo soltanto si avvicina a lui per riferirgli qualcosa: si tratta di Poskrebyshev, la sua fedele guardia del corpo.
(Risate nell’aula).
Dove è il comando militare? Dove il Politburo? Dov’è il governo? Cosa mai stanno facendo? Cosa li tiene occupati? Nel film essi non esistono e Stalin agisce al posto di tutti: egli non riconosce alcuno, non si consulta con alcuno. Ogni cosa viene mostrata alla nazione in questa falsa luce. Perché? Per circondare Stalin di gloria, contrariamente alla realtà o alla verità storica.
Sorge una domanda: dove sono i militari sulle cui spalle ricadeva il peso della guerra? Essi non sono presenti nel film; accanto a Stalin non vi è posto per loro.
Non fu Stalin, ma furono il partito nel suo complesso, il governo sovietico, il nostro eroico esercito, i suoi intelligenti capi e valorosi soldati, l’intera nazione sovietica ad assicurare la vittoria nella grande guerra patriottica .
(Applausi scroscianti e prolungati nell’aula).
I membri del Comitato Centrale, i ministri, i nostri esperti economici, gli esponenti della cultura sovietica, i direttori delle organizzazioni sovietiche e delle sedi locali del partito e del governo, gli ingegneri ed i tecnici, ognuno al suo posto di lavoro, contribuirono generosamente con la loro energia e con la loro competenza ad assicurare la vittoria sul nemico.
Un eccezionale eroismo fu dimostrato dal nucleo vitale del nostro popolo. La gloria avvolge tutta la nostra classe lavoratrice: dai contadini dei kolkos all’intelligentzia sovietica che, sotto la direzione degli organi del partito, seppe superare indicibili ostacoli sopportando i disagi della guerra, dedicando tutte le sue energie alla causa della difesa della patria.
Imprese coraggiose ed importanti furono compiute dalle donne sovietiche che sopportarono sulle loro spalle il pesante onere della produzione negli stabilimenti, nei kolkos e nei vari settori economici e culturali; molte donne parteciparono direttamente alla guerra patriottica sui vari fronti. La nostra valorosa gioventù diede un contributo incommensurabile, sia sul fronte che nelle retrovie, difendendo la patria sovietica e sterminando il nemico.
Degni di gloria immortale sono i servizi resi dai soldati sovietici e dai loro comandanti, dai lavoratori politici di ogni rango; dopo l’annientamento di notevole parte dell’esercito, nei primi mesi di guerra, non persero la testa e seppero riorganizzarsi mentre i combattimenti proseguivano. Essi crearono a rafforzarono, mentre la guerra continuava, un esercito forte ed eroico che non solo seppe resistere alla pressione di un nemico forte ed astuto ma anche annientarlo.
Le magnifiche imprese di centinaia di milioni di persone, in oriente ed occidente, durante la lotta contro la minaccia di un dominio fascista che pendeva su di noi, rimarranno per secoli e millenni nella memoria dell’umanità grata.
(Applausi scroscianti).
La parte principale e il merito maggiore della vittoriosa conclusione della guerra spettano al partito comunista, alle forze armate dell’Unione Sovietica e a decine di milioni di cittadini sovietici educati dal partito.
(Applausi scroscianti e prolungati).
Discorso di Gandhi alla Conferenza delle relazioni inter-asiatiche, New Delhi, 2 aprile 1947
Chi era Gandhi? Partire dalla risposta a questa domanda – che di per sé è complessissima – aiuta però a comprendere molto delle sue scelte e della sua visione, sia teorica che soprattutto pratica del mondo, e le sue scelte verso l’indipendenza dell’India.
Tutte le battaglie di Gandhi sono le battaglie di un avvocato che conosce il diritto, la sua forza e i suoi principi, e li usa, da persona colta, contro chi lo ha promulgato e ne chiede il rispetto.
La sua politica indipendentista si gioca su un principio fondamentale che verrà ripreso nelle lotte per i diritti civili in tutto il mondo, non solo dai movimenti indipendentisti e anti-coloniali.
Se un cittadino paga le tasse, deve rispettare le leggi, i codici civili e penali, sottostare alle procedure di quei codici, deve svolgere il servizio militare, deve adottare documenti e permessi governativi, allora deve anche poter votare.
Questo significava sostanzialmente che – per numero di cittadini – le potenze europee come Francia e soprattutto Inghilterra, avrebbero avuto parlamenti nazionali con membri in maggioranza provenienti dalle colonie. E all’inaccettabilità di questa ipotesi, fece corrispondere il rifiuto ad accettare tutti gli altri obblighi. Perché, per gli stessi fondamenti del diritto occidentale, non può esistere un principio giuridico che preveda solo obblighi senza diritti.
Mohandas Karamchand Gandhi nasce il 2 ottobre 1869 a Porbandar. La sua famiglia appartiene alla comunità modh, gruppo tradizionalmente dedito al commercio: il nome Gandhi significa infatti “droghiere”. Nei primi anni di scuola Gandhi viene poco apprezzato. Segue poi gli studi superiori presso Rajkot, dove il padre si era trasferito per ricoprire l’incarico di Primo ministro del locale principato.
All’età di diciotto anni, tre anni dopo la tragica morte del padre, parte per studiare da avvocato presso la University College di Londra. Considerando l’impossibilità di rispettare i precetti induisti in Inghilterra, la sua casta si oppone alla partenza. Gandhi parte nonostante le discordie e per questo viene dichiarato fuori casta dal capo della sua comunità.
A Londra Gandhi si adatta alle abitudini inglesi, vestendosi e cercando di vivere come un gentleman.
Due giorni dopo aver passato gli esami di giurisprudenza parte dall’Inghilterra, il 12 giugno 1891, per tornare in India: una volta sbarcato a Bombay apprende che la madre era morta. Con l’aiuto del fratello viene riammesso nella sua casta e inizia a praticare l’avvocatura; avrà però difficoltà ad esercitare la sua professione: le sue conoscenze sono soprattutto teoriche e non conosce ancora bene il diritto indiano. Inoltre è imbarazzato nel parlare in pubblico
Ritorna allora a Rajkot per lavorare con suo fratello, facendo il lavoro di avvocato. Due anni dopo, la ditta indiana Dada Abdullah & C., che commercia nel Natal, lo incarica di difendere una causa in Sudafrica.
In Sudafrica entra in contatto con l’apartheid (segregazione dei neri). Ma viene soprattutto a contatto con il pregiudizio razziale e con le condizioni di quasi schiavitù nelle quali vivono i suoi 150 mila connazionali. Questa situazione lo porterà a un’evoluzione interiore profonda. Diversi aneddoti sono stati raccontati direttamente da Gandhi a titolo di «esperienze di verità» e meritano di essere riportati per capire questo cambiamento: un giorno, in un tribunale di Durban, il magistrato gli domanda di togliere il turbante. Gandhi si rifiuta di obbedire e viene espulso dal tribunale. Si fa espellere anche da un treno a Pietermaritzburg, non avendo accettato di passare dal vagone di prima classe in quello di terza classe, dato che possedeva un biglietto valido per la prima classe. In seguito prende una diligenza ed il responsabile prima gli vieta di viaggiare all’interno con gli altri passeggeri europei e poi lo picchia perché si rifiuta di spostarsi sul predellino
Dopo aver lasciato definitivamente il Sudafrica nel 1914, giunge in Inghilterra al momento dello scoppio della guerra contro la Germania: offre il suo aiuto nel servizio di ambulanza, ma una pleurite mal curata lo costringe a ritornare in India. Vi giunge il 9 gennaio 1915: sbarca nel porto di Mumbai dove viene festeggiato come un eroe nazionale. Il leader del Congresso indiano Gopal Krishna Gokhale gli suggerisce un anno di “silenzio politico”, nel corso del quale è invitato a viaggiare in treno per conoscere la vera India: Gandhi accetta e decide di percorrere il paese in lungo e in largo, di villaggio in villaggio, per incontrare l’anima indiana e conoscerne i bisogni. Così per tutto il 1915, Gandhi viaggia per conoscere la condizione dei villaggi indiani il cui numero si eleva a 700.000.
Il 18 marzo 1919 viene approvato dal governo britannico il Rowlatt Act, che estende in tempo di pace le restrizioni di libertà entrate in vigore durante la guerra. Gandhi si oppone con un movimento di disobbedienza civile che ha inizio il 6 aprile, con uno spettacolare hartal, uno sciopero generale della nazione con astensione di massa dal lavoro, accompagnato da preghiera e digiuno. Gandhi viene arrestato. Scoppiano disordini in tutta l’India, tra cui il massacro di Amritsar (13 aprile) nel Punjab, durante il quale le truppe britanniche guidate dal generale Edward H. Dyer massacrano centinaia di civili e ne feriscono a migliaia: i rapporti ufficiali parlano di 389 morti e 1000 feriti, mentre altre fonti parlano di oltre 1000 morti. Il massacro genera un trauma in tutta la nazione accrescendo la collera della popolazione. Questo genera diversi atti di violenza a seguito dei quali Gandhi, facendo autocritica, sospende la campagna satyagraha.
Dopo questo massacro Gandhi critica sia le azioni del Regno Unito, sia le violente rappresaglie degli indiani esponendo la sua posizione in un toccante discorso nel quale evidenzia il principio che la violenza è malefica e non può essere giustificata.
Gandhi allarga il suo principio di non-violenza al movimento Swadeshi puntando all’autonomia e all’autosufficienza economica del paese, attraverso l’utilizzo dei beni locali, vedendola come una parte del più ampio obiettivo della Swaraj. “Swadeshi” significava “autosufficienza” dell’India dall’economia inglese, puntando sulla produzione interna alla nazione dei prodotti necessari alla popolazione. A questo proposito nell’agosto del 1931 Gandhi aveva affermato:
« Un paese rimane in povertà, materiale e spirituale, se non sviluppa il suo artigianato e le sue industrie e vive una vita da parassita importando manufatti dall’estero »
Inizia così il boicottaggio dei prodotti stranieri, in particolare di quelli inglesi; soprattutto un settore viene visto come essenziale, quello tessile
« I tessuti che importiamo dall’Occidente hanno letteralmente ucciso milioni di nostri fratelli e sorelle »
Nel marzo del 1930 intraprende una campagna contro la tassa del sale e il regime che l’aveva alzata. Inizia così la celebre Marcia del sale che parte con settantotto satyagrahi dall’ashram Sabarmati di Ahmedabadil 12 marzo e termina a Dandi il 6 aprile 1930 dopo 380 km di marcia. Arrivati sulle coste dell’Oceano indiano Gandhi ed i suoi sostenitori estraggono il sale in aperta violazione del monopolio reale e vengono imitati dalle migliaia di indiani unitisi durante la marcia.
Questa campagna, una delle più riuscite della storia dell’indipendenza non-violenta dell’India, viene brutalmente repressa dall’impero britannico, che reagisce imprigionando più di 60 000 persone. Anche Gandhi e molti membri del Congresso vengono arrestati. Diversi satyagrahi vengono inoltre picchiati dalle autorità durante i loro tentativi di razzia non-violenta di saline e di depositi di sale.
Signora Presidente e amici, non credo di dovermi scusare con voi per il fatto che sono costretto a parlare in una lingua straniera. Chissà se questi altoparlanti porteranno la mia voce fino ai confini di questo immenso pubblico. Quelli di voi che sono lontani possono alzare la mano, se sentono quello che dico? Sentite? Bene. Bene, se la mia voce non vi giunge, non è colpa mia, ma colpa degli altoparlanti.
Quello che volevo dirvi è che non devo scusarmi. Non oso, visti tutti i delegati che si sono riuniti qua da tutta l’Asia, e gli osservatori – ho imparato questa parola pronunciata da un amico americano che disse: “Non sono un delegato, sono un osservatore”. Di primo impatto con lui, vi assicuro, pensavo venisse dalla Persia, ma ecco davanti a me un americano e gli dico: “Sono terrorizzato da te, e vorrei che mi lasciassi stare”. Potete immaginare un americano che mi lasci stare? Non lui e, quindi, ho dovuto parlargli.
Quello che volevo dirvi è che il mio idioma per me madrelingua, non lo potete capire, e non voglio insultarvi insistendo su di esso. Il linguaggio nazionale, Hindustani, ci metterà tanto tempo prima di rivaleggiare con un linguaggio internazionale.
Se ci deve essere rivalità, c’è rivalità tra francese e inglese. Per il commercio internazionale, indubbiamente l’inglese occupa il primo posto. Per discorsi e corrispondenza diplomatici, sentivo dire quando studiavo da ragazzo che il francese era la lingua della diplomazia e se volevi andare da una parte all’altra dell’Europa dovevi provare ad imparare un po’ di francese, e quindi ho provato ad imparare qualche parola di francese per riuscire a farmi capire. Comunque, se ci deve essere rivalità, la rivalità potrebbe nascere tra francese e inglese. Quindi, avendo imparato l’inglese, è naturale che faccia ricorso a questa parlata internazionale per rivolgermi a voi.
Mi chiedevo di cosa dovessi parlarvi. Volevo raccogliere i miei pensieri, ma lasciate che sia onesto con voi, non ne ho avuto il tempo.
Però ieri ho comunque promesso che avrei provato a dirvi qualche parola.
Mentre venivo con Badshah Khan, ho chiesto un piccolo pezzo di carta ed una matita. Ho ricevuto una penna invece di una matita. Ho provato a scarabocchiare qualche parola. Vi spiacerà sentirmi dire che quel pezzo di carta non è qui con me. Ma questo non importa, ricordo cosa volevo enunciare, e mi sono detto: “I miei amici non hanno visto la vera India, e non ci stiamo incontrando in una conferenza nel cuore della vera India”.
Delhi, Bombay, Madras, Calcutta, Lahore – queste sono tutte grandi città e quindi, hanno subito l’influenza dell’Occidente, sono state fatte, magari eccetto Delhi ma non New Delhi, sono state fatte dagli inglesi. Poi ho pensato ad un breve saggio – credo che dovrei chiamarlo così – che era in francese. Era stato tradotto per me da un amico anglo-francese, e lui era un filosofo, era anche un uomo altruista e diceva che mi aveva dato la sua amicizia senza che io lo conoscessi, perché lui parteggiava per le minoranze ed io rappresentavo, assieme ai miei connazionali, una minoranza senza speranze, e non solo senza speranze ma una minoranza disprezzata.
Se gli europei del Sudafrica mi perdonano per quello che dico, eravamo tutti “coolies” [lavoratore non qualificato a basso costo]. Io ero un insignificante avvocato “coolie”. A quei tempi non avevamo dottori “coolie”, non avevamo avvocati “coolie”. Ero il primo nel campo. Ma sempre un “coolie”. Magari sapete cosa si intende con la parola “coolie” ma questo mio amico, si chiamava Krof – sua madre era francese, suo padre inglese – disse: “Voglio tradurre per te una storia francese”.
Mi perdonerete, chi di voi sa la storia, se nel ricordarla faccio degli errori qua e là, ma non ci sarà nessun errore nell’avvenimento principale.
C’erano tre scienziati e – ovviamente è una storia inventata – tre scienziati uscirono dalla Francia, uscirono dall’Europa alla ricerca della “Verità”. Questa era la prima lezione che mi aveva insegnato quella storia, che se bisogna cercare la verità, non la si trova su suolo europeo. Quindi, indubbiamente neanche in America.
Questi tre grandi scienziati andarono in parti diverse dell’Asia. Uno trovò la strada per l’India e diede inizio alla sua ricerca. Raggiunse le cosiddette città di quei tempi. Naturalmente, ciò avvenne prima dell’occupazione inglese, prima anche del periodo Mughal, così è come ha illustrato la storia l’autore francese, ma visitò comunque le città, vide la gente delle cosiddette caste alte, uomini e donne, fino a che non si addentrò in un’umile casa, in un umile villaggio, e quella casa era una casa Bhangi, e trovò la verità che stava cercando, in quella casa Bhangi, nella famiglia Bhangi, uomo, donna, forse 2 o 3 bambini (lo dico come me lo ricordo) e poi lui descrive come la trovò. Tralascio tutto questo.
Voglio collegare questa storia a quello che voglio dire a voi, che se volete vedere il meglio dell’India, dovete trovarlo in una casa Bhangi, in un’umile casa Bhangi, o villaggi simili, 700.000 come ci insegnano gli storici inglesi. Un paio di città qua e là, non ospitano neanche qualche crore [unità di misura indiana che equivale a 10 milioni] di persone. Ma i 700.000 villaggi ospitano quasi 40 crore di persone. Ho detto quasi perché potremmo togliere una o due crore che stanno in città, comunque sarebbero 38 crore.
E poi mi sono detto, se questi amici sono qui senza trovare la vera India, per cosa saranno venuti? Ho poi pensato che vi pregherò di immaginare quest’India, non dal punto di vista di questo immenso pubblico ma per come potrebbe essere. Vorrei che leggeste una storia come questa storia dei francesi o altre ancora. Magari, qualcuno di voi vada a vedere qualche villaggio dell’India e allora troverà la vera India.
Oggi farò anche questa ammissione: non ne sarete affascinati alla vista. Dovrete raschiare sotto i mucchi di letame che sono oggi i nostri villaggi. Non voglio dire che siano mai stati dei paradisi. Ma oggi sono veramente dei mucchi di letame; non erano così prima, di questo sono abbastanza certo. Non l’ho appreso dalla storia ma da quello che ho visto io stesso dell’India, fisicamente con i miei occhi; e io ho viaggiato da una parte all’altra dell’India, ho visto i villaggi, i miserabili esemplari dell’umanità, gli occhi senza vita, eppure sono l’India, e ciononostante in quelle umili case, nel mezzo dei mucchi di letame troviamo gli umili Bhangis, dove troverete un concentrato di saggezza. Come? Questa è una grande domanda.
Bene, allora voglio illustrarvi un altro scenario. Di nuovo, ho imparato dai libri, libri scritti da storici inglesi, tradotti per me. Tutta questa ricca conoscenza, mi spiace dire, arriva qui da noi in India attraverso i libri inglesi, attraverso gli storici inglesi, non che non ci siano storici indiani ma neanche loro scrivono nella loro madrelingua, o nella loro lingua nazionale, Hindustani, o se preferite chiamarli due idiomi, Hindi e Urdu, due forme della stessa lingua. No, ci riferiscono quello che hanno studiato sui libri inglesi, magari gli originali, ma attraverso gli inglesi in inglese, questa è la conquista culturale dell’India, che l’India ha subito.
Ma ci dicono che la saggezza è arrivata dall’Occidente verso l’Oriente. E chi erano questi saggi? Zoroastro. Lui apparteneva all’Oriente. Fu seguito dal Buddha. Lui apparteneva all’Oriente, apparteneva all’India. Chi ha seguito il Buddha? Gesù, di nuovo dall’Asia. Prima di Gesù ci fu Musa, Mosè, che apparteneva anche lui alla Palestina, ma verificavo con Badshah Khan e Yunus Saheb ed entrambi sostenevano che Mosè appartenesse alla Palestina, sebbene fosse nato in Egitto. Poi venne Gesù, poi Mohammad. Tutti loro li tralascio. Tralascio Krishna, tralascio Mahavir, tralascio le altre luci, non le chiamerò luci minori, ma sconosciute in Occidente, sconosciute al mondo letterario.
In ogni modo, non conosco una singola persona che possa uguagliare questi uomini d’Asia. E poi cosa accadde? Il Cristianesimo, arrivando in Occidente, si è trasfigurato. Mi spiace dire questo, ma questa è la mia lettura. Non dirò altro al riguardo. Vi racconto questa storia per incoraggiarvi e per farvi capire, se il mio povero discorso può farvi capire, che lo splendore che vedete e tutto quello che vi mostrano le città indiane non è la vera India. Certamente, il massacro che avviene sotto i vostri occhi, mi dispiace, vergognoso come dicevo ieri, dovete seppellirlo qui. Il ricordo di questo massacro non deve oltrepassare i confini dell’India, ma quello che voglio voi capiate, se potete, è che il messaggio dell’Oriente, dell’Asia, non deve essere appreso attraverso la lente occidentale, o imitando gli orpelli, la polvere da sparo, la bomba atomica dell’Occidente.
Se volete dare di nuovo un messaggio all’Occidente, deve essere un messaggio di “Amore”, un messaggio di “Verità”.
Ci deve essere una conquista (applausi) per favore, per favore, per favore. Questo interferisce con il mio discorso, e interferisce anche con la vostra comprensione. Voglio catturare i vostri cuori, e non voglio ricevere i vostri applausi. Fate battere i vostri cuori all’unisono con le mie parole, e io credo che il mio lavoro sarà compiuto.Voglio lasciarvi con il pensiero che l’Asia debba conquistare l’Occidente. Poi, la domanda che mi ha fatto un mio amico ieri: “Se credevo in un mondo unico?”. Certo, credo in un mondo unico. Come posso fare diversamente, quando divento erede di un messaggio di amore che questi grandi, inconquistabili maestri ci hanno lasciato? Potete esprimere questo messaggio di nuovo ora, in questa era di democrazia, nell’era del risveglio dei più poveri dei poveri, potete esprimere questo messaggio con maggiore enfasi. Poi completerete la conquista di tutto l’Occidente, non attraverso la vendetta perché siete stati sfruttati, e nello sfruttamento voglio ovviamente includere l’Africa, e spero che quando vi rincontrerete in India la prossima volta ci sarete tutti: spero che voi, nazioni sfruttate della terra, vi incontrerete, se a quell’epoca ci saranno ancora nazioni sfruttate.
Ho forte fiducia che se unite i vostri cuori, non solo le vostre menti, e capite il segreto dei messaggi che i saggi uomini d’Oriente ci hanno lasciato, e che se veramente diventiamo, meritiamo e siamo degni di questo grande messaggio, allora capirete facilmente che la conquista dell’Occidente sarà stata completata e che questa conquista sarà amata anche dall’Occidente stesso.
L’Occidente di oggi desidera la saggezza. L’Occidente di oggi è disperato per la proliferazione della bomba atomica, perché significa una completa distruzione, non solo dell’Occidente, ma la distruzione del mondo, come se la profezia della Bibbia si avverasse e ci fosse un vero e proprio diluvio universale. Voglia il cielo che non ci sia quel diluvio, e non a causa degli errori degli umani contro se stessi. Sta a voi consegnare il messaggio al mondo, non solo all’Asia, e liberare il mondo dalla malvagità, da quel peccato.
Questa è la preziosa eredità che i vostri maestri, i miei maestri, ci hanno lasciato.
De Gasperi, Discorso alla Conferenza di pace di Parigi, 10 agosto 1946
Alcide De Gasperi si presenta alla conferenza di pace di Parigi, a un anno dalla fine della seconda guerra mondiale, da primo presidente del consiglio dopo il fascismo.
L’Italia è una paese duplice agli occhi del mondo. È un paese sconfitto dagli alleati, che fu tra i più fieri alleati di Hitler e del nazismo. Ma è anche un paese che in gran parte si è liberato da solo, con circa due anni di lotte partigiane: una seconda guerra mondiale nella seconda guerra mondiale. Non senza ferite laceranti che resteranno nella storia del nostro paese.
De Gasperi gode del rispetto personale dei leader presenti alla conferenza, e del prestigio che il mondo gli riconosce. Lui e gli altri ministri sono consapevoli che la solidità della situazione istituzionale Italia dipende anche e soprattutto dal risultato di questa conferenza di pace, per evitare che nuovi sentimenti revanscisti spingano ad estremismi di qualsiasi tipo in un paese a metà tra cattolici e comunisti sul confine mediano di un’Europa che si annuncia divisa e fragile.
Il peso sulle spalle di De Gasperi è enorme, ed è consapevole che questo sarà solo uno dei momenti topici che nei mesi successivi caricheranno su di lui e sul suo governo le fragili sorti dell’Italia.
De Gasperi nacque e si formò nell’allora Tirolo Italiano, ovvero Trentino, regione che all’epoca era parte dell’Impero austro-ungarico. Dopo la laurea entrò a far parte della redazione del giornale Il Trentino e in breve tempo assunse la carica di direttore, scrisse una serie di articoli con cui difendeva l’autonomia culturale del Trentino a fronte del Tirolo tedesco, ma non mise mai in discussione l’appartenenza di tutto il Tirolo all’Impero austro-ungarico.
Nelle elezioni del Parlamento austriaco del 13 e 20 giugno 1911 venne eletto tra le file dei Popolari: nel suo collegio elettorale di Fiemme-Fassa-Primiero-Civezzano, di 4275 elettori, ottenne ben 3116 voti. Il 27 aprile 1914 ottenne anche un seggio nella Dieta Tirolese di Innsbruck. Anche il suo impegno di Parlamentare fu legato alla difesa dell’autonomia delle popolazioni trentine. La sua attività propagandistica finì con l’essere tenacemente avversata dagli organi polizieschi in seguito al precipitare degli eventi internazionali: l’attentato di Sarajevo che determinò lo scoppio della prima guerra mondiale e soprattutto l’adesione dell’Italia allaTriplice intesa.
Inizialmente De Gasperi sperò che l’Italia entrasse in guerra a fianco dell’Austria-Ungheria e della Germania sulla base della Triplice alleanza.
Nel maggio 1918, quando ormai l’impero austro-ungarico stava crollando, fu tra i promotori di un documento comune sottoscritto dalle rappresentanze dei polacchi, dei cechi, degli slovacchi, dei rumeni, degli sloveni, dei croati e dei serbi. Il successivo 24 ottobre partecipò alla formazione del Fascio nazionale, comprendente popolari liberali trentini e liberali giuliani e adriatici.
Dopo il passaggio del Trentino all’Italia nel 1919, accettò e prese la cittadinanza italiana.
Nel 1919 aderì al Partito Popolare Italiano promosso da don Luigi Sturzo; solo nel 1921 venne eletto deputato a Roma, in quanto il Trentino fino a quell’epoca era stato sottoposto a regime commissariale.
Nel 1922 si sposa con Francesca Romani. Nello stesso anno il 16 novembre a seguito del discorso del bivacco votò la fiducia al governo Mussolini. Al tempo delle dimissioni di Don Sturzo da segretario del PPI De Gasperi era capogruppo alla Camera. Il 20 maggio 1924 assunse la segreteria del Partito popolare, carica che manterrà fino al 14 dicembre 1925.
Dopo l’iniziale sostegno del suo partito nella prima parte del governo Mussolini, tanto che nel 1923 i popolari cercarono inizialmente di trovare un compromesso sulla legge Acerbo, De Gasperi tenne un discorso alla Camera dei Deputati il 15 luglio 1923 esplicando il suo atteggiamento verso quella legge. Successivamente si oppose all’avvento del fascismo finché, isolato dal regime, fu arrestato alla stazione di Firenze l’11 marzo 1927, insieme alla moglie, mentre si stava recando in treno a Trieste. Al processo che seguì venne condannato a 4 anni di carcere e a una forte multa.
Dopo la scarcerazione, alla fine del luglio 1928, venne continuamente sorvegliato dalla polizia e dovette trascorrere un periodo di grandi difficoltà economiche e isolamento sia morale che politico. Senza un impiego stabile, provò a presentare domanda presso la Biblioteca Apostolica Vaticana nell’autunno 1928, contando sull’interessamento del vescovo di Trento, mons. Celestino Endrici, e di alcuni amici ex popolari. L’assunzione – come collaboratore soprannumerario – venne il 3 aprile 1929, dopo la firma dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929).
Nel 1942-43, durante la Seconda Guerra mondiale, compose, insieme ad altri, l’opuscolo Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana in cui esprimeva le idee alla base del futuro partito della Democrazia Cristiana di cui sarebbe stato cofondatore.
Una volta liberato il sud Italia a opera delle forze anglo-americane, entrò a far parte in rappresentanza della Democrazia Cristiana nel Comitato di Liberazione Nazionale. Durante il governo guidato da Ivanoe Bonomi fu ministro senza portafoglio, mentre dal dicembre del 1944 al dicembre del 1945 venne nominato ministro degli esteri.
Nel 1945 fu nominato presidente del Consiglio dei Ministri, l’ultimo del Regno d’Italia. Durante tale governo fu proclamata la Repubblica e perciò fu anche il primo capo di governo dell’Italia repubblicana, e guidò un governo di unità nazionale, che durò fino al 1947 quando il Presidente degli Stati Uniti Truman ordinò l’espulsione dei partiti socialcomunisti dai governi dell’Europa Occidentale.
Da ricordare che dall’esilio di Umberto II il 13 giugno del 1946, quando il consiglio dei ministri da lui presieduto aveva proceduto alla proclamazione della repubblica prima che la Corte di Cassazione ratificasse i risultati definitivi del referendum del 2 e 3 giugno, alla sua carica fu connessa la funzione accessoria di capo provvisorio dello Stato: in quelle ore si ebbe il drammatico scambio di battute con Falcone Lucifero, ministro della monarchia, in cui De Gasperi affermò: «O lei verrà a trovare me a Regina Coeli, o io verrò a trovare lei». I poteri accessori della Presidenza del Consiglio ebbero termine contestualmente all’elezione di Enrico De Nicola come Capo provvisorio dello Stato il 28 giugno da parte dell’Assemblea Costituente.
Nel gennaio 1947 ebbe luogo la celebre missione di De Gasperi negli Stati Uniti, nel corso della quale lo statista conseguì un importante successo politico con l’ottenere dalle autorità americane un prestito eximbank di 100 milioni di dollari. L’apertura di un dialogo costruttivo tra i due paesi conferì a De Gasperi la motivazione e il sostegno necessari ad attuare l’ambizioso disegno di un nuovo governo senza le sinistre e con l’apporto di un gruppo di “tecnici” guidati da Luigi Einaudi. La formazione del quarto gabinetto De Gasperi contribuirà a ripristinare la credibilità dell’azione di governo, consentendo l’adozione della strategia antinflazionistica nota come “linea Einaudi”.
Nell’occasione fu il terzo italiano a essere onorato di una ticker-tape parade dalla città di New York, e sarà l’unico a ripeterne l’esperienza, nel 1951.
In un’Italia oberata dal ricordo di vent’anni di dittatura fascista e spaventosamente logorata dalla Seconda guerra mondiale, De Gasperi affrontò con dignità politica le trattative di pace con le nazioni vincitrici, che porteranno alla firma del Trattato di Parigi fra l’Italia e le potenze alleate, riuscendo a confinare le inevitabili sanzioni principalmente all’ambito del disarmo militare (che con il tempo sarebbero state superate andando a decadere), ed evitando la perdita di territori di confine come l’Alto-Adige (riguardo il quale lo statista trentino firmerà anche il famoso Accordo De Gasperi-Gruber) e la Valle d’Aosta. Cercò inoltre di risolvere a vantaggio dell’Italia la questione della sovranità dell’Istria e di Trieste, ove però ebbe meno successo dovendo accettare la perdita della prima in favore della neonata Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia guidata da Tito e l’istituzione delTerritorio libero di Trieste soggetto all’autorità anglo-americana nella seconda. Finanziò una rivista, Terza generazione, il cui scopo era di unire i giovani di là dai partiti e superare la divisione tra fascisti e antifascisti.
L’equilibrio del discorso qui riproposto sta nell’umiltà nel presentare ai vincitori le richieste per l’Italia e al contempo la dignità nel pretendere rispetto per un paese che ha combattuto il fascismo.
Una duplicità che tiene conto della contingenza storica, della verità storica, e della prospettiva di equilibrio in politica interna.
“Signori Delegati, grava su voi la responsabilità di dare al mondo una pace che corrisponda ai conclamati fini della guerra, cioè all’indipendenza e alla fraterna collaborazione dei popoli liberi. … vi chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica d’Italia: un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano.”
Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale
cortesia, è contro di me: e sopratutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare
come imputato e l’essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro
conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Non corro io il rischio di apparire come uno
spirito angusto e perturbatore, che si fa portavoce di egoismi nazionali e di interessi unilaterali?
Signori, è vero: ho il dovere innanzi alla coscienza del mio Paese e per difendere la vitalità del
mio popolo di parlare come italiano; ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche
come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica che,
armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universaliste del
cristianesimo e le speranze internazionaliste dei lavoratori, è tutta rivolta verso quella pace
duratura e ricostruttiva che voi cercate e verso quella cooperazione fra i popoli che avete il
compito di stabilire.
Ebbene, permettete che vi dica con la franchezza che un alto senso di responsabilità impone in
quest’ora storica a ciascuno di noi, questo trattato è, nei confronti dell’Italia, estremamente
duro; ma se esso tuttavia fosse almeno uno strumento ricostruttivo di cooperazione
internazionale, il sacrificio nostro avrebbe un compenso: l’Italia che entrasse, sia pure vestita
del saio del penitente, nell’ONU, sotto il patrocinio dei Quattro, tutti d’accordo nel proposito di
bandire nelle relazioni internazionali l’uso della forza (come proclama l’art. 2 dello Statuto di
San Francisco) in base al « principio della sovrana uguaglianza di tutti i Membri», come è detto
allo stesso articolo, tutti impegnati a garantirsi vicendevolmente «l’integrità territoriale e
l’indipendenza politica», tutto ciò potrebbe essere uno spettacolo non senza speranza e
conforto. L’Italia avrebbe subito delle sanzioni per il suo passato fascista, ma, messa una pietra
tombale sul passato, tutti si ritroverebbero eguali nello spirito della nuova collaborazione
internazionale.
Si può credere che sia così?
Evidentemente ciò è nelle vostre intenzioni, ma il testo del trattato parla un altro linguaggio.
In un congresso di pace è estremamente antipatico parlar d’armi e di strumenti di guerra. Vi
devo accennare, tuttavia, perché nelle precauzioni prese dal trattato contro un presumibile
riaffacciarsi di un pericolo italiano si è andati tanto oltre da rendere precaria la nostra capacità
difensiva connessa con la nostra indipendenza. Mai, mai nella nostra storia moderna le porte di
casa furono così spalancate, mai le nostre possibilità di difesa così limitate. Ciò vale per la
frontiera orientale come per certe rettifiche dell’occidentale ispirate non certo ai criteri della
sicurezza collettiva. Né questa volta ci si fa balenare la speranza di Versailles, cioè il proposito
di un disarmo generale, del quale il disarmo dei vinti sarebbe solo un anticipo.
Ma in verità più che il testo del trattato, ci preoccupa lo spirito: esso si rivela subito nel
preambolo. Il primo considerando riguarda la guerra di aggressione e voi lo ritroverete tale
quale in tutti i trattati coi così detti ex-satelliti; ma nel secondo considerando che riguarda la
cobelligeranza voi troverete nel nostro un apprezzamento sfavorevole che cercherete invano
nei progetti per gli Stati ex-nemici. Esso suona: «considerando che sotto la pressione degli
avvenimenti militari, il regime fascista fu rovesciato…». Ora non v’ha dubbio che il
rovesciamento del regime fascista non fu possibile che in seguito agli avvenimenti militari, ma
il rivolgimento non sarebbe stato così profondo, se non fosse stato preceduto dalla lunga
cospirazione dei patrioti che in Patria e fuori agirono a prezzo di immensi sacrifici, senza
l’intervento degli scioperi politici nelle industrie del nord, senza l’abile azione clandestina degli
uomini dell’opposizione parlamentare antifascista (ed è qui presente uno dei suoi più fattivi
rappresentanti) che spinsero al colpo di stato. Rammentate che il comunicato di Potsdam del 2
agosto 1945 proclama: « l’Italia fu la prima delle Potenze dell’Asse a rompere con la Germania,
alla cui sconfitta essa diede un sostanziale contributo ed ora si è aggiunta agli Alleati nella
guerra contro il Giappone».
«L’Italia ha liberato se stessa dal regime fascista e sta facendo buoni progressi verso il ristabilimento di un Governo e istituzioni democratiche».
Tale era il riconoscimento di Potsdam. Che cosa è avvenuto perché nel preambolo del trattato si
faccia ora sparire dalla scena storica il popolo italiano che fu protagonista? Forse che un
governo designato liberamente dal popolo, attraverso l’Assemblea Costituente della Repubblica,
merita meno considerazione sul terreno democratico? La stessa domanda può venir fatta circa
la formulazione così stentata ed agra della cobelligeranza: « delle Forze armate italiane hanno
preso parte attiva alla guerra contro la Germania». Delle Forze? Ma si tratta di tutta la marina
da guerra, di centinaia di migliaia di militari per i servizi di retrovia, del «Corpo Italiano di
Liberazione», trasformatosi poi nelle divisioni combattenti e «last but not least» dei partigiani,
autori sopratutto dell’insurrezione del nord. Le perdite nella resistenza contro i tedeschi, prima
e dopo la dichiarazione di guerra, furono di oltre 100 mila uomini tra morti e dispersi, senza
contare i militari e civili vittime dei nazisti nei campi di concentramento ed i 50 mila patrioti
caduti nella lotta partigiana.
Diciotto mesi durò questa seconda guerra, durante i quali i tedeschi indietreggiarono
lentamente verso nord spogliando, devastando, distruggendo quello che gli aerei non avevano
abbattuto.
Il rapido crollo del fascismo dimostrò esser vero quello che disse Churchill: «un uomo, un
uomo solo ha voluto questa guerra» e quanto fosse profetica la parola di Stimson, allora
Ministro americano della guerra: «la resa significa un atto di sfida ai tedeschi che avrebbe
cagionato al popolo italiano inevitabili sofferenze».
Ma è evidente che, come la prefazione di un libro, anche il preambolo è stato scritto dopo il
testo del Trattato, e così bisognava ridurre, attenuare il significato della partecipazione del
popolo italiano ed in genere della cobelliggeranza perché il preambolo potesse in qualche
maniera corrispondere agli articoli che seguono.
Infatti dei 78 articoli del trattato la più parte corrisponde ai due primi considerando, cioè alla
guerra fascista e alla resa: nessuno al considerando della cobelligeranza, la quale si ritiene già
compensata coll’appoggio promesso all’Italia per l’entrata nell’ONU; compenso garantito
anche a Stati che seguirono o poterono seguire molto più tardi l’esempio dell’Italia antifascista.
Il carattere punitivo del trattato risulta anche dalle clausole territoriali. E qui non posso negare
che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile
superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall’inizio da una psicologia di
guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata
tregua fra le due parti più direttamente interessate.
Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945. Abbandonando la frontiera naturale delle
Alpi e per soddisfare alle aspirazioni etniche Jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva
fatto propria quando, il 28 aprile 1919, nella Conferenza della Pace a Parigi invocava «una
decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione tra vincitori e
vinti».
Proponevamo inoltre che il problema economico della Venezia Giulia venisse risolto
internazionalizzando il porto di Trieste e creando una collaborazione col porto di Fiume e col
sistema ferroviario Danubio-Sava-Adriatico.
Era naturalmente inteso che si dovesse introdurre parità e reciprocità nel trattamento delle
minoranze, che Fiume riavesse lo status riconosciuto a Rapallo, che il carattere di Zara fosse
salvaguardato.
Il giorno dopo, Signori Ministri, avete deciso di cercare la linea etnica in modo che essa
lasciasse il minimo di abitanti sotto dominio straniero: a tale scopo disponeste la costituzione
di una Commissione d’inchiesta. La commissione lavorò nella Venezia Giulia per 28 giorni. Il
risultato dell’inchiesta fu tale che io stesso, chiamato a Parigi a dire il mio avviso il 3 maggio
1946, ne approvai, sia pure con alcune riserve, le conclusioni di massima. Ma i rappresentanti
iugoslavi insistettero, con argomenti di sapore punitivo, sul possesso totale della Venezia
Giulia e specie di Trieste. Cominciò allora l’affannosa ricerca del compromesso e, quando
lasciai Parigi, correva voce che gli Anglo-Americani, abbandonando le linee etniche, si
ritirassero su quella francese. Questa linea francese era già una linea politica di comodo, non
più una linea etnica nel senso delle decisioni di Londra, perché rimanevano nel territorio slavo
180.000 italiani e in quello italiano 59.000 slavi; sopratutto essa escludeva dall’Italia Pola e le
città minori della costa istriana occidentale ed implicava quindi per noi una perdita
insopportabile. Ma per quanto inaccettabile, essa era almeno una frontiera italo-jugoslava che
aggiudicava Trieste all’Italia. Ebbene, che cosa è accaduto sul tavolo del compromesso durante
il giugno, perché il 3 luglio il Consiglio dei Quattro rovesciasse le decisioni di Londra e facesse
della linea francese non più la frontiera fra Italia e Jugoslavia, ma quella di un cosiddetto
«Territorio libero di Trieste» con particolare statuto internazionale? Questo rovesciamento fu
per noi una amarissima sorpresa e provocò in Italia la più profonda reazione. Nessun sintomo,
nessun cenno poteva autorizzare gli autori del compromesso a ritenere che avremmo assunto
la benché minima corresponsabilità di una simile soluzione che incide nelle nostre carni e mutila
la nostra integrità nazionale. Appena avuto sentore di tale minaccia, il 30 giugno telegrafavo ai
Quattro Ministri degli Esteri la pressante preghiera di ascoltarmi dichiarando di volere
assecondare i loro sforzi per la pace, ma mettendoli in guardia contro espedienti che sarebbero
causa di nuovi conflitti. La soluzione internazionale, dicevo, com’è progettata, non è accettabile
e specialmente l’esclusione dell’Istria occidentale fino a Pola causerà una ferita insopportabile
alla coscienza nazionale italiana.
La mia preghiera non ebbe risposta e venne messa agli atti. Oggi non posso che rinnovarla,
aggiungendo degli argomenti che non interessano solo la nostra nazione, ma voi tutti che siete
ansiosi della pace del mondo.
Il Territorio libero, come descritto dal progetto, avrebbe una estensione di 783 kmq. con
334.000 abitanti concentrati per 3/4 nella città capitale. La popolazione si comporrebbe,
secondo il censimento del 1921, di 266.000 italiani, 49.501 slavi, 18.000 altri. Lo Stato
sarebbe tributario della Jugoslavia e dell’Italia in misura eguale per la forza elettrica,
comunicherebbe col suo hinterland con tre ferrovie slave e una italiana. Le spese necessarie
per il bilancio ordinario sarebbero di 5 a 7 miliardi; il gettito massimo dei tributi potrebbe
toccare il miliardo. Trieste e il suo porto dall’Italia hanno avuto dal 1919 al 1938 larghissimi
contributi per opere pubbliche e le industrie triestine come i cantieri, le raffinerie, le fabbriche
di conserve, non solo sono sorte in seguito a facilitazioni, esenzioni fiscali, sussidi (anche le linee
di navigazione), ma sono vincolate tutte ai mercati italiani. Già ora il trattato proietta la sua
ombra sull’attività produttiva di Trieste perché non si crede alla vitalità della sistemazione e
alla sua efficienza economica. Come sarà possibile, obiettano i triestini, di mantenere l’ordine in
uno Stato non accetto né agli uni né agli altri, se oggi ancora gli Alleati, che pur vi mantengono
forze notevoli, non riescono a garantire la sicurezza personale?
Il problema interno è forse il più grave. Ogni gruppo etnico chiederebbe soccorso ai suoi e le
lotte si complicherebbero col sovrapporsi del problema sociale, particolarmente acuto e violento
in situazioni come quelle di un emporio commerciale e industriale. Come farà l’ONU ad
arbitrare e ad evitare che le lotte politiche interne assumano carattere internazionale?
Voi rinserrate nella fragile gabbia d’uno statuto i due contendenti con razioni scarse e copiosi
diritti politici e voi pretendete che non vengano alle mani e non chiamino in aiuto gli slavi,
schierati tutto all’intorno a 8 chilometri di distanza, e gl’italiani che tendono il braccio
attraverso un varco di due chilometri?
Ovvero pensate davvero di fare del porto di Trieste un emporio per l’Europa Centrale? Ma allora
il problema è economico e non politico. Ci vuole una compagnia, un’amministrazione
internazionale, non uno Stato; un’impresa con stabili basi finanziarie, non una combinazione
giuridica collocata sulle sabbie mobili della politica!
Per correre il rischio di tale non durevole espediente, voi avete dovuto aggiudicare l’81% del
territorio della Venezia Giulia agli iugoslavi (ed ancor essi se ne lagnano come di un tradimento
degli Alleati, e cercano di accaparrare il resto a mezzo di formule giuridiche costituzionali del
nuovo Stato); avete dovuto far torto all’Italia rinnegando la linea etnica, avete abbandonato
alla Jugoslavia la zona di Parenzo-Pola, senza ricordare la Carta Atlantica che riconosce alle
popolazioni il diritto di consultazione sui cambiamenti territoriali, anzi ne aggravate le
condizioni stabilendo che gli italiani della Venezia Giulia passati sotto la sovranità slava che
opteranno per conservare la loro cittadinanza, potranno entro un anno essere espulsi e
dovranno trasferirsi in Italia abbandonando la loro terra, le loro case, i loro averi, che più? i
loro beni potranno venir confiscati e liquidati, come appartenenti a cittadini italiani all’estero,
mentre l’italiano che accetterà la cittadinanza slava sarà esente da tale confisca.
L’effetto di codesta vostra soluzione è che, fatta astrazione dal Territorio libero, 180.000 italiani
rimangono in Jugoslavia e 10 mila slavi in Italia (secondo il censimento del 1921) e che il totale
degli italiani esclusi dall’Italia calcolando quelli di Trieste, è di 446.000; né per queste
minoranze avete minimamente provveduto, mentre noi in Alto Adige stiamo preparando una
generosa revisione delle opzioni ed è già stato raggiunto un accordo su una ampia autonomia
regionale da sottoporsi alla Costituente.
A qual pro dunque ostinarsi in una soluzione che rischia di creare nuovi guai, a qual pro voi vi
chiuderete gli orecchi alle grida di dolore degli italiani del’lstria — ho presente una sottoscrizione di Fola — che sono pronti a partire, ad abbandonare terre e focolari pur di non sottoporsi al nuovo regime?
Lo so, bisogna fare la pace, bisogna superare la stasi, ma se avete rinviato d’un anno la
questione coloniale, non avendo trovato una soluzione adeguata, come non potreste fare
altrettanto per la questione giuliana? C’è sempre tempo per commettere un errore irreparabile.
Il trattato sta in piedi anche se rimangono aperte alcune clausole territoriali. È una pace
provvisoria: ma anche da Versailles a Cannes si dovette procedere per gradi. Altre questioni
rimangono aperte o sono risolte nel Trattato negativamente. Non posso ritenere, ad es., che i
nostri rapporti con la Germania si possano considerare definiti con l’art. 87 di codesto Trattato,
il quale impone all’Italia la rinuncia a qualsiasi reclamo, compresi i crediti contro la Germania e
i cittadini germanici fino alla data dell’8 maggio 1945, dopo cioè che l’Italia era in guerra con la
Germania da diciannove mesi.
I nostri tecnici calcolano a circa 700 miliardi di lire, cioè a circa 3 miliardi di dollari, la somma
che possiamo reclamare dalla Germania per il periodo della cobelligeranza; e noi ci dovremo
semplicemente rinunciare? Non può essere questo un provvedimento definitivo; bisognerà pur
riparlarne quando si farà la pace con la Germania: e allora non è questo un altro argomento
per provare che il completo assestamento d’Europa non può avvenire che dopo la pace con la
Germania? Stabiliamo le basi fondamentali del trattato; l’Italia accetterà di fare i sacrifici che può.
Mettiamoci poi a tavolino, noi e gli iugoslavi in prima linea, e cerchiamo un modo di vita, una
collaborazione, perché senza questo spirito le formule del trattato rimarranno vuote.
Non è a dire con ciò che per tutto il resto il trattato sia senz’altro accettabile.
Alcune clausole economiche sono durissime. Così per esempio l’art. 69 che concede ad ogni
Potenza Alleata od Associata il diritto di sequestrare, ritenere o liquidare tutti i beni italiani
all’estero, salvo restituire la eventuale quota eccedente i reclami delle Nazioni Unite.
L’applicazione generale di tale articolo avrebbe conseguenze insopportabili per la nostra
economia. Ci attendiamo che tali disposizioni vengano modificate sopratutto se — come non
dubito — si darà modo ai miei collaboratori di esprimersi a fondo su questo come su ogni altro
argomento, in seno alle competenti Commissioni. Così ancora all’art. 62 ci si impone una rinuncia
contraria al buon diritto e alle norme internazionali, la rinuncia cioè a qualsiasi credito
derivante dalle Convenzioni sul trattamento dei prigionieri.
Logica conseguenza della cobelligeranza è anche che a datare dal 13 ottobre 1943 lo spirito con
cui devono essere regolati i rapporti economici tra noi e gli Alleati sia diverso. Non si tratta più
di spese di occupazione, previste all’epoca dell’armistizio per un breve periodo, ma di spese di
guerra sul fronte italiano. Ad esse il Governo italiano vuole contribuire nei limiti delle sue
possibilità economiche, ma nei modi che di tale capacità tengano conto.
In quanto alle riparazioni, pur essendo disposti a sopportare sacrifici, dobbiamo escludere che
si facciano gravare sull’economia italiana oneri imprecisati e per un tempo indeterminato e nei
riguardi dei territori ceduti o liberati si dovrà tener conto degli enormi investimenti da noi fatti
per opere pubbliche per lo sviluppo culturale e materiale di tali paesi. Se : clausole del trattato ci
venissero imposte nella loro totalità e crudezza, noi, firmando, commetteremmo un falso perché
l’Italia, nel momento attuale, con una diminuzione dei salari reali di oltre il 50% e del reddito
nazionale di oltre il 45%, ha già visto ridurre la sua capacità di produzione fino al punto da non
poter acquistare all’estero le derrate alimentari e le materie prime. Ulteriori peggioramenti
provocherebbero il caos monetario, l’insolvenza e la perdita della nostra indipendenza
economica. A che ci gioverebbe allora essere ammessi ai benefici del Consiglio economico e
sociale dell’ONU?
Prendiamo atto con soddisfazione che nella Conferenza dei Quattro — seduta del 10 maggio —
la proposta di affidare all’Italia sotto forma di amministrazione fiduciaria le sue colonie ha
incontrato consensi. Confidiamo che tale assenso trovi pratica applicazione nel momento di deliberare.
In tale attesa, purché non si chiedano rinunce preventive, non facciamo obiezioni al
rinvio né al prolungamento dell’attuale regime di controllo militare in quei territori. Ma noi ci
attendiamo che l’amministrazione di quei territori durante l’anno di proroga sia, in conformità
della legge internazionale, affidata almeno per un’equa parte ai funzionari italiani, sia pure sotto
il controllo delle autorità occupanti. E facciamo viva istanza perché decine e decine di migliaia
di profughi dalla Libia, Eritrea e Somalia che vivono in condizioni angosciose in Italia o in campi di
concentramento della Rhodesia o nel Kenya possano ritornare alle loro sedi.
Circa le questioni militari, le nostre obiezioni potranno più propriamente essere esposte nella
Commissione rispettiva. Basti qui riaffermare che la flotta italiana, dopo essersi data tutta alla
cobelligeranza e aver operato in favore della causa comune per tre anni e fino a tutt’oggi sotto
propria bandiera agli ordini del Comando Supremo del Mediterraneo, non può oggi, per ovvie
ragioni morali e giuridiche, venir trattata come bottino di guerra. Ciò non esclude che nello
spirito degli accordi Cunningham-De Courten, essa contribuisca entro giustificati limiti a
restituzioni o compensi.
Signori Ministri, Signori Delegati
Per mesi e mesi ho atteso invano di potervi esprimere in una sintesi generale il pensiero
dell’Italia sulle condizioni della sua pace, ed oggi ancora comparendo qui nella veste di ex nemico,
veste che non fu mai quella del popolo italiano, innanzi a Voi, affaticati dal lungo
travaglio o anelanti alla conclusione, ho fatto uno sforzo per contenere il sentimento e dominare
la parola, onde sia palese che siamo lungi dal voler intralciare ma intendiamo costruttivamente
favorire la vostra opera, in quanto contribuisca ad un assetto più giusto del mondo.
Chi si fa interprete oggi del popolo italiano è combattuto da doveri apparentemente contrastanti.
Da una parte egli deve esprimere l’ansia, il dolore, l’angosciosa preoccupazione per le
conseguenze del trattato, dall’altra riaffermare la fede della nuova democrazia italiana nel
superamento della crisi della guerra e nel rinnovamento del mondo operato con validi strumenti di pace.
Tale fede nutro io pure e tale fede sono venuti qui a proclamare con me i miei due autorevoli
colleghi, l’uno già Presidente del Consiglio, prima che il fascismo stroncasse l’evoluzione
democratica dell’altro dopoguerra, il secondo Presidente dell’Assemblea Costituente Repubblicana,
vittima ieri dell’esilio e delle prigioni e animatore oggi di democrazia e di giustizia
sociale: entrambi interpreti di quell’Assemblea a cui spetterà di decidere se il trattato che
uscirà dai vostri lavori sarà tale da autorizzarla ad assumerne la corresponsabilità, senza
correre il rischio di compromettere la libertà e lo sviluppo democratico del popolo italiano.
Signori Delegati,
grava su voi la responsabilità di dare al mondo una pace che corrisponda ai conclamati fini
della guerra, cioè all’indipendenza e alla fraterna collaborazione dei popoli liberi. Come italiano
non vi chiedo nessuna concessione particolare, vi chiedo solo di inquadrare la nostra pace nella
pace che ansiosamente attendono gli uomini e le donne di ogni paese, che nella guerra hanno
combattuto e sofferto per una meta ideale. Non sostate sui labili espedienti, non illudetevi con
una tregua momentanea o con compromessi instabili: guardate a quella meta ideale, fate uno
sforzo tenace e generoso per raggiungerla.
È in questo quadro di una pace generale stabile, Signori Delegati, che vi chiedo di dare respiro e
credito alla Repubblica d’Italia: un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad associare la sua
opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano.
Roosevelt 1941 – Il giorno dell’infamia
Il primo mandato di Roosevelt si aprì a poche settimane dall’insediamento di Hitler in Germania e dalla decisione giapponese di lasciare la Società delle Nazioni, due episodi che mostravano la fragilità degli equilibri mondiali. La crisi economica internazionale condizionò pesantemente anche la politica estera di Roosevelt.
Il primo mandato della presidenza di Roosevelt fu caratterizzato, come egli stesso programmò il giorno dell’insediamento, da una “politica di buon vicinato, quella di chi ha il massimo rispetto per se stesso e così facendo rispetta anche i diritti degli altri”.
Ciò si tradusse nella continuazione del disimpegno militare americano in America Latina, avviato dai suoi predecessori repubblicani.
La convenzione democratica, riunitasi nel giugno 1936, confermò con entusiasmo Roosevelt quale candidato alle elezioni presidenziali di quell’anno. Egli esaltò i risultati raggiunti con il New Deal e promise di continuare su quella strada. I repubblicani invece condannavano tali provvedimenti e accusavano il presidente di aver usurpato i poteri del Congresso scegliendo come candidato un repubblicano progressista, Alf Landon dal Kansas, l’unico governatore repubblicano che era riuscito a mantenere la carica nelle elezioni del 1932, vinte in maniera schiacciante dai democratici.
I toni della campagna elettorale furono spesso aspri: Roosevelt usò parole dure contro gli uomini dell’alta finanza; in cambio i repubblicani lo accusarono di essere un demagogo privo di principi morali. I risultati delle elezioni invece diedero a Roosevelt una vittoria ancora più marcata e netta di quattro anni prima: egli ottenne quasi ventotto milioni di voti (pari al 60,80%), vinse in ben 46 stati su 48 e conquistò la cifra record di 523 grandi elettori contro i soli 8 di Landon. Il partito del presidente ottenne tre quarti dei seggi al Senato e i quattro quinti della Camera dei rappresentanti. Il voto dimostrò l’appoggio del popolo americano alle politiche di Roosevelt e bocciò sonoramente l’opposizione repubblicana.
Con una mossa senza precedenti, Roosevelt cercò un terzo mandato consecutivo nel 1940.
Fino a quel momento tutti i presidenti avevano rispettato la regola non scritta stabilita da George Washington, che nel 1793 aveva rinunciato al terzo mandato affermando che troppo potere non doveva essere accentrato per troppo tempo nelle mani di un solo uomo. In seguito, nel 1951, questa regola fu resa esplicita con un emendamento costituzionale; pertanto Roosevelt rimarrà per sempre l’unico presidente ad avere svolto più di due mandati consecutivi.
Sebbene molti nel Partito Democratico vedessero che Roosevelt era già sofferente, al punto che non si era certi che potesse ricoprire un quarto mandato, non ci fu quasi discussione sul fatto che, in tempo di guerra, sarebbe stato il candidato del partito nelle elezioni del 1944.
Tenendo conto della salute di Roosevelt, convinsero il senatore del Missouri Harry Truman a formare la coppia di candidati democratici nel 1944. La coppia Roosevelt e Truman vinse le elezioni, tenutesi il 7 novembre 1944, sconfiggendo lo sfidante, il popolare repubblicano Dewey.
Nel 1941 gli interessi contrapposti del Giappone e degli Stati Uniti in Asia e nel Pacifico, specialmente in Cina, produssero una rottura delle relazioni diplomatiche al punto che la guerra sembrava inevitabile. Roosevelt finanziò largamente le spese di guerra con emissioni di titoli a lungo termine emessi dal Tesoro, i Titoli Serie E, ideati dal suo amico ed allora segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Henry Morgenthau
Il 14 gennaio 1943 Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aereo durante la carica, con il suo volo da Miami al Marocco per incontrare Winston Churchill e discutere della seconda guerra mondiale. L’incontro si concluse il 24 gennaio. Tra il 4 e l’11 febbraio del 1945 partecipò, insieme a Stalin e Churchill, alla Conferenza di Jalta, il più famoso degli incontri nei quali fu deciso quale sarebbe stato l’assetto politico internazionale al termine della guerra.
Il suo messaggio al Congresso e alla nazione l’8 dicembre 1941, dopo l’attacco di Pearl Harbor, entrò nella storia con la frase: «Il 7 dicembre 1941 – una data che vivrà nell’infamia». Dopo questo discorso gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale a fianco degli Alleati.
Nel 2000 il fotografo Robert Stinnett, dopo un lungo lavoro di ricerca, ha riproposto la teoria della cospirazione architettata da Roosevelt e i suoi collaboratori per indurre i giapponesi ad attaccare Pearl Harbor; le tesi di Stinnett in sintesi sono che Roosevelt avrebbe applicato un piano per provocare l’attacco giapponese contro gli Stati Uniti e che all’ammiraglio Kimmel sarebbe stato impedito di condurre esercitazioni che avrebbero fatto scoprire la flotta giapponese in arrivo, flotta che in realtà, secondo Stinnett, non avrebbe mantenuto il silenzio radio e, anzi, i suoi messaggi sarebbero stati intercettati e decifrati dai servizi statunitensi. Il lavoro di Stinnett è stato tuttavia fortemente criticato da altri studiosi, che lo hanno smentito in vari modi, e le sue deduzioni sono state ritenute non esatte.
I servizi segreti britannici e dell’FBI avevano delle informative su possibili attacchi a quasi tutte le installazioni militari statunitensi (sabotaggi, attacchi aerei o navali, spionaggio) attribuite alle potenze dell’Asse o all’URSS (percepita già dai servizi informativi dell’FBI come la maggiore minaccia).
La possibilità di un attacco a Pearl Harbor arrivò a John Edgar Hoover, l’allora direttore dell’FBI, attraverso dei contatti informali con i servizi segreti britannici, che passarono agli USA il loro agente Dušan Popov, al servizio dei tedeschi ma in realtà doppiogiochista schierato con gli Alleati. Popov informò i suoi superiori sull’attenzione mostrata dai giapponesi verso l’attacco di Taranto e le installazioni militari alle Hawaii.
In ogni caso l’FBI non ritenne Popov affidabile e non prese in considerazione le sue soffiate, ostinandosi inoltre a non collaborare con i servizi segreti britannici. Subito dopo l’attacco Hoover si accorse di aver commesso un grave errore, diventando uno dei registi occulti delle teorie cospirative contro Roosevelt in modo da creare una cortina di nebbia attorno alla propria negligenza.
Ieri, 7 dicembre 1941 – una data che resterà segnata dall’infamia – gli Stati Uniti d’America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati da forze aeree e navali dell’Impero del Giappone.
Gli Stati Uniti con loro erano in pace e su sollecitazione Giapponese, eravamo ancora in fase di colloquio, col loro governo e con l’imperatore, per mantenere questo status nel area Pacifica.
In realtà, un’ora dopo squadroni aerei giapponesi aveva iniziato i bombardamenti sull’isola americana di Oahu, l’Ambasciatore giapponese negli Stati Uniti e il suo collega hanno consegnato al nostro Segretario di Stato una risposta formale ad un recente messaggio americano. Sebbene questa risposta affermava che sembrava inutile proseguire i negoziati diplomatici in corso, non conteneva alcuna minaccia o accenno di guerra o attacco armato.
Verrà ricordato che la distanza delle Hawaii dal Giappone rende evidente che l’attacco sia stato deliberatamente programmato molti giorni o addirittura settimane fa. Nel contempo il governo giapponese ha intenzionalmente cercato di ingannare gli Stati Uniti con false dichiarazioni e espressioni di speranza a favore di una pace duratura.
L’attacco di ieri sulle isole hawaiane ha causato gravi danni alle navali americane e alle forze militari. Mi spiace dirvi che molti americani hanno perso la vita.
Inoltre, le navi americane sono state bersaglio di siluri in alto mare tra San Francisco e Honolulu.
Ieri il governo giapponese ha anche lanciato un attacco contro Malaya.
La scorsa notte le forze giapponesi hanno attaccato Hong Kong.
La scorsa notte le forze giapponesi hanno attaccato Guam.
La scorsa notte le forze giapponesi hanno attaccato le Isole Filippine.
Ieri sera, i giapponesi hanno attaccato Wake Island.
E questa mattina, i giapponesi hanno attaccato le Isole Midway.
Il Giappone ha dunque intrapreso un’offensiva a sorpresa estesa a tutta l’area del Pacifico. I fatti di ieri e di oggi parlano da soli. Il popolo degli Stati Uniti si è già fatto un opinione e ben comprende le implicazioni per la vita e la sicurezza della nostra nazione.
Come comandante in capo della Marina militare ho disposto che tutte le possibili misure siano prese per la nostra difesa, noi ricorderemo in quale maniera siamo stati attaccati.
Non importa quanto tempo ci dovremo prendere per superare questa invasione premeditata, il popolo americano, con la forza della ragione, vincerà con un vittoria schiacciante.
Credo di interpretare la volontà del Congresso e del popolo, quando dico che non solo ci difenderemo fino all’ultimo, ma faremo in modo che questa forma di tradimento, per noi, non sia mai più un pericolo.
L’ ostilità esiste. Non vi è alcun dubbio per il fatto che il nostro popolo, il nostro territorio e i nostri interessi siano in grave pericolo.
Con la totale fiducia nelle nostre forze armate, con l’illimitata determinazione del nostro popolo, si otterrà l’inevitabile trionfo. Così Dio ci aiuti.
Chiedo che il Congresso dichiari che, fin dall’attacco non provocato e codardo da parte del Giappone della Domenica, 7 dicembre 1941, esista uno stato di guerra tra gli Stati Uniti e l’Impero giapponese.
Mussolini dichiarazione di guerra
Come per Hitler, anche per Mussolini questa lunga premessa di inquadramento storico è utile per comprendere la struttura e la natura del simmetrico discorso di “dichiarazione di guerra”.
Entrambi arrivano al potere sulla base della fragilità politica interna, degli interessi della grande industria e come argine all’avanzata socialista. Mentre Hitler parla in parlamento, in forma diretta e “lunga”, con un discorso che avrà come eco la sua diffusione a mezzo stampa, Mussolini parla direttamente in piazza, in un apparente “discorso breve a braccio”.
Molte volte si è fatto riferimento all’ammirazione che Hitler aveva verso Mussolini, e a ragion veduta. Il primo schivo, a tratti introverso se non timido, accompagnava la sua retorica a forti momenti scenografici che ne esaltavano ruolo e posizione in monologhi incontrastati, quasi monolitici. Mussolini abituato alla dialettica, al confronto, spesso aspro, delle sezioni sindacali, del partito socialista di provincia, in anni di “lotta contadina”, può essere considerato il primo caso di uso diretto del mezzo di comunicazione di massa (giornali, radio, cinegiornali) per aggregare il consenso (tipico delle dittature del primo novecento) ma anche contemporaneamente il primo caso di disintermediazione comunicativa.
Abituato a stare “in mezzo” alla gente, a non poche apparizioni “dirette”, fisicamente in prima persona, apparentemente spontanee (in realtà studiate nel minimo dettaglio) appare “la guida del popolo tra e dal popolo”.
A Roma, per intenderci, dovremmo attendere la visita del papa a san Lorenzo dopo i bombardamenti e papa Giovanni per avere qualcosa di simile, che almeno sino ai tempi di Berlinguer, difficilmente diverrà icona collettiva altrettanto popolarmente concepita.
Mussolini non affidava i suoi discorsi di maggiore importanza alla stampa o ad altri, ma interveniva direttamente nella bonifica dell’agro pontino quanto all’inaugurazione della Fiat o alla mietitura del grano (tre esempi diametralmente opposti tra loro) quanto alla traversata del Tevere.
Questa consapevolezza del ruolo della comunicazione disintermediata – frutto della sua storia personale e della sua formazione – fu anche quello che lo rese così “diverso” dagli altri leader di partito – che apparivano distaccati e ingessati, anche quando rappresentanti di partiti popolari e di massa, come socialisti e repubblicani – e che rese così difficile l’azione anche solo di propaganda dei suoi oppositori interni.
La stabilità della dittatura fascista è in gran parte da ascriversi alla capacità di Mussolini di generare attorno alla propria figura un forte consenso. L’abilità mostrata nel rendere la sua personalità oggetto di vero e proprio culto si rifletté non solo nell’approvazione che la società italiana a lungo gli mostrò, ma anche nell’ammirazione che riuscì a guadagnarsi presso numerosi capi di Stato stranieri, intellettuali e, più in generale, presso l’opinione pubblica internazionale, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Da questo punto di vista Mussolini divenne un modello di ispirazione per molti futuri dittatori, soprattutto Hitler, ma anche per molti politici di spicco di importanti stati democratici.
La popolarità di Mussolini trova probabilmente la sua origine nell’insoddisfazione del popolo italiano nei confronti delle classi dirigenti liberali per via dei trattati di pace, ritenute dai più sfavorevoli, che l’Italia aveva dovuto accettare alla fine della prima guerra mondiale, nonostante gli oltre 650.000 morti e i sacrifici enormi sopportati dal Paese. Non a caso, Gabriele D’Annunzio parlò di «vittoria mutilata». L’Italia guadagnò territorialmente solo parte di ciò che le era stato promesso col patto di Londra e ciò, unito al generale malcontento post-bellico e alla terribile crisi economica dell’immediato dopoguerra, fece crescere il desiderio di un governo forte.
Mussolini fu abile a sfruttare tale situazione nonché la paura del cosiddetto “pericolo rosso”, accresciutasi durante il biennio rosso: si presentò come il restauratore dell’ordine e della pace sociale, teso alla «normalizzazione» della situazione politica. A partire dal 1925, con la promulgazione delle cosiddette leggi fascistissime e l’inizio della dittatura, ogni forma di collaborazione coi vecchi partiti fu abbandonata e gli stessi sciolti.
Il consenso fu poi alimentato grazie al controllo sulla stampa e sul mondo culturale italiano.
Mussolini conosceva bene il potere della stampa, e di conseguenza fece in modo di poterlo controllare. Nei suoi Colloqui con Emil Ludwig giustificò la censura imposta ai giornali con il fatto che nelle liberaldemocrazie i giornali non sarebbero più liberi, ma obbedirebbero solo ad un’oligarchia di padroni, differenti dallo Stato: partiti e finanziatori plutocratici.
Ogni forma di dissenso sgradita a Mussolini venne repressa attraverso l’OVRA, il Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato, e l’uso massiccio del confino politico. Tuttavia, Mussolini tollerò – e costrinse i suoi a tollerare – alcune “voci fuori dal coro” (Salvemini, Croce, Bombacci) ciò che per oltre un decennio alimentò la sua immagine di uomo forte ma non di tiranno, e per mantenere aperti canali di dialogo anche con l’antifascismo militante.
Benito Amilcare Andrea Mussolini fu innanzitutto un giornalista ed esponente di spicco del Partito Socialista Italiano.
Nel contesto di forte instabilità politica e sociale successivo alla Grande Guerra, puntò alla presa del potere; forzando la mano alle istituzioni, con l’aiuto di atti di squadrismo e d’intimidazione politica che culminarono il 28 ottobre 1922 con la marcia su Roma, Mussolini ottenne l’incarico di costituire il Governo (30 ottobre). Dopo il contestato successo alle elezioni politiche del 1924, instaurò nel gennaio 1925 la dittatura, risolvendo con forza la delicata situazione venutasi a creare dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti. Negli anni successivi consolidò il regime, affermando la supremazia del potere esecutivo, trasformando il sistema amministrativo e inquadrando le masse nelle organizzazioni di partito.
Nel 1935, Mussolini decise di occupare l’Etiopia, provocando l’isolamento internazionale dell’Italia. Appoggiò quindi i franchisti nella guerra civile spagnola e si avvicinò alla Germania nazista di Adolf Hitler, con il quale stabilì un legame che culminò con il Patto d’Acciaio nel 1939. È in questo periodo che furono approvate in Italia le leggi razziali.
Nel 1940, ritenendo ormai prossima la vittoria della Germania, fece entrare l’Italia nella seconda guerra mondiale. In seguito alle disfatte subite dalle Forze Armate italiane e alla messa in minoranza durante il Gran consiglio del fascismo (ordine del giorno Grandi del 24 luglio 1943), fu arrestato per ordine del re (25 luglio) e successivamente tradotto a Campo Imperatore. Liberato dai tedeschi, e ormai in balia delle decisioni di Hitler, instaurò nell’Italia settentrionale la Repubblica Sociale Italiana. In seguito alla definitiva sconfitta delle forze italo-tedesche, abbandonò Milano la sera del 25 aprile 1945, dopo aver invano cercato di trattare la resa. Il tentativo di fuga si concluse il 27 aprile con la cattura da parte dei partigiani a Dongo, sul lago di Como.
Mussolini emigrò il 9 luglio 1902 in Svizzera per sfuggire al servizio militare obbligatorio, stabilendosi a Losanna. Lì si iscrisse al sindacato muratori e manovali, di cui poi divenne segretario, e il 2 agosto 1902 pubblicò il suo primo articolo su L’Avvenire del lavoratore, il giornale dei socialisti svizzeri.
Fino a novembre visse in Svizzera, spostandosi di città in città e svolgendo lavori occasionali. Venne espulso due volte dal paese: il 18 giugno 1903 fu arrestato a Berna come agitatore socialista, trattenuto in carcere per 12 giorni e poi espulso il 30 giugno dal Canton Berna, mentre il 9 aprile 1904 venne incarcerato per 7 giorni a Ginevra a causa del permesso di soggiorno falsificato, per poi essere espulso una settimana dopo dal Canton Ginevra. Nel frattempo ricevette anche una condanna a un anno di carcere per renitenza alla leva militare. Venne protetto da alcuni socialisti e anarchici del Canton Ticino, tra cui Giacinto Menotti Serrati e Angelica Balabanoff.
Nel novembre 1904, caduta la condanna per renitenza alla leva in seguito all’amnistia concessa in occasione della nascita dell’erede al trono Umberto, Mussolini tornò in Italia. Dovette tuttavia presentarsi al Distretto militare di Forlì e adempì ai suoi doveri di leva venendo assegnato il 30 dicembre 1904 al 10º Reggimento bersaglieri di Verona. Poté tornare a casa con una licenza per assistere la madre morente (19 gennaio 1905). Poi riprese il servizio militare, ottenendo al termine una dichiarazione di buona condotta per il contegno disciplinato.
Allo scoppio della prima guerra mondiale interpretò con fermezza la linea non interventista dell’Internazionale Socialista. Mussolini era del parere che il conflitto non poteva giovare agli interessi dei proletari italiani bensì solo a quelli dei capitalisti. Nello stesso periodo, all’insaputa dell’opinione pubblica, il Ministero degli Esteri stava avviando un’operazione di persuasione negli ambienti socialisti e cattolici per ottenere un atteggiamento favorevole verso un possibile intervento dell’Italia in guerra.
Riguardo agli ambienti socialisti, individuò nel quotidiano del partito uno strumento per portare i socialisti dalla propria parte. Fu Filippo Naldi, “faccendiere” con numerosi agganci tra gli ambienti finanziari e il giornalismo (e direttore del bolognese Resto del Carlino), a prendere contatti con il direttore dell’Avanti.
Il 26 luglio Mussolini pubblicò un editoriale intitolato Abbasso la guerra, a favore della scelta anti-bellicista; ma negli stessi giorni compaiono altri articoli, a firme di noti esponenti del partito, che pur mantenendo fermo l’atteggiamento di fondo contro la guerra cominciavano a discutere sull’alleato che avrebbe potuto giovare alla causa italiana. Già nei primi mesi del conflitto appariva quindi tutta l’incertezza del Partito Socialista, che non sapeva risolversi tra la sua inclinazione antimilitarista e la propensione verso la guerra come mezzo per rinnovare la lotta politica e smuovere gli equilibri consolidati nel Paese.
Uno dei primi a porre dubbi sulla neutralità assoluta fu Bissolati, a cui seguirono Prezzolini, Salvemini, i repubblicani, i radicali, i massoni, i socialisti riformisti e i sindacalisti rivoluzionari. I primi attacchi a Mussolini relativi ad un suo possibile cambio d’opinione si ebbero il 28 agosto 1914 in un articolo de “Giornale d’Italia” e continuarono in settembre e ottobre su altri quotidiani. Fu in questo contesto che Naldi pubblicò un polemico articolo sul Resto del Carlino (7 ottobre 1914, scritto da Libero Tancredi), in cui accusava Mussolini di doppiogiochismo, ottenendo l’irata reazione del direttore dell’Avanti!
Il 18 ottobre, mutando esplicitamente la propria originaria posizione, Mussolini pubblicò sulla Terza pagina dell’Avanti! un lungo articolo intitolato «Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante», in cui rivolse un appello ai socialisti sul pericolo che una neutralità avrebbe comportato per il partito, cioè la condanna all’isolamento politico. Secondo Mussolini, le organizzazioni socialiste avrebbero dovuto appoggiare la guerra fra le nazioni, con la conseguente distribuzione delle armi al popolo, per poi trasformarla in una rivoluzione armata contro il potere borghese.
La nuova linea non venne accettata dal partito e nel giro di due giorni Mussolini rassegnò le dimissioni (20 ottobre). Nel periodo di direzione Mussolini, il giornale era salito da 30-45.000 copie nel 1913 a 60-75.000 copie nei primi mesi del 1914.
Grazie all’aiuto finanziario di alcuni gruppi industriali Mussolini riuscì rapidamente a fondare un suo giornale: Il Popolo d’Italia, il cui primo numero uscì il 15 novembre 1914. Dalle colonne del suo giornale, Mussolini attaccò senza remore i suoi vecchi compagni. Col partito era rottura: il 29 novembre Mussolini venne espulso dal PSI.
I tempi dell’operazione e la provenienza dei finanziamenti insospettirono gli ex compagni, che accusarono Mussolini di indegnità morale. Secondo il Partito Socialista, egli avrebbe ricevuto fondi occulti da agenti francesi in Italia, che lo avrebbero corrotto per farlo aderire alla causa dell’interventismo pro-Intesa.
La questione finì davanti alla commissione d’inchiesta del collegio dei probiviri dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, che escluse ogni ipotesi di corruzione giungendo alla conclusione che la nascita del giornale era da collegarsi esclusivamente al rapporto di simpatia personale fra Mussolini e il direttore del Carlino Naldi.
Solo negli ultimi anni stanno uscendo documenti che proverebbero invece il diretto intervento del governo francese a favore di Mussolini, che comunque sappiamo aver incontrato in Svizzera rappresentanti dell’Intesa, i quali gli assicurano il loro appoggio.
In particolare, secondo una nota scritta nel novembre 1922 dai servizi segreti francesi a Roma, Mussolini avrebbe incassato nel 1914 dal deputato francese Charles Dumas, capo di gabinetto del ministro francese Jules Guesde, socialista, dieci milioni di franchi “per caldeggiare sul suo Popolo d’Italia l’entrata in guerra dell’Italia al fianco delle potenze alleate”.
Nel mese di dicembre prese parte a Milano alla fondazione dei “Fasci di azione rivoluzionaria” di Filippo Corridoni, partecipando poi al loro primo congresso il 24 e il 25 gennaio 1915.
La fondazione dei Fasci italiani di combattimento avvenne a Milano il 23 marzo 1919 in Piazza San Sepolcro; stando allo stesso Mussolini non erano presenti che una cinquantina di aderenti, ma negli anni successivi, quando la qualifica di sansepolcrista dava automaticamente diritto a vantaggi cospicui in termini economici e di prestigio sociale, furono centinaia coloro che riuscirono a far aggiungere alla lista il loro nome.
Tra marzo e giugno i futuristi di Filippo Tommaso Marinetti divennero la componente principale del Fascio milanese e fecero sentire la loro influenza ideologica; tuttavia Mussolini ebbe modo di affermare: “Noi siamo, soprattutto, dei libertari cioè della gente che ama la libertà per tutti, anche per avversari. (…) Faremo tutto il possibile per impedire la censura e preservare la libertà di pensiero di parola, la quale costituisce una delle più alte conquiste ed espressioni della civiltà umana”.
Dall’esperienza dei Freikorps tedeschi trasse la conclusione che squadre di uomini armati potevano essere utilissime per intimidire l’opposizione: il 15 aprile 1919, subito dopo un comizio della Camera del Lavoro all’Arena Civica, fascisti, arditi, nazionalisti e allievi ufficiali, guidati da Marinetti e Ferruccio Vecchi si lanciarono contro la sede dell’Avanti!, attaccandola e devastandola, dopo una serie di colluttazioni stradali con gruppi socialisti e dopo che dalla sede del giornale venne sparato un colpo di pistola che uccise un soldato, Martino Speroni. Mussolini si tenne in disparte, credendo che i suoi uomini non fossero ancora pronti per combattere una “battaglia di strada”, ma difese il fatto compiuto. Procedette quindi a reclutare un esercito di arditi pronti a vari assalti frontali e trasportò nella sede del Popolo d’Italia una grande quantità di materiali bellici, per prevenire un possibile “contrattacco rosso”.
Il 24 e il 25 maggio 1920 Mussolini partecipò al secondo Congresso dei Fasci di combattimento, che si teneva al teatro lirico di Milano. I Fasci di combattimento, grazie alla progressiva svolta a destra, iniziarono ad avere finanziamenti da parte di industriali, i quali venivano in cambio protetti da squadre di arditi. In giugno si schierò a favore di Giolitti, con il quale in ottobre s’incontrò per la risoluzione della questione di Fiume: pur biasimandolo per aver ritirato le truppe dall’Albania, gli fece capire che un accordo con i liberalconservatori era possibile. Il 12 novembre, con il fondo L’accordo di Rapallo, commentò abbastanza favorevolmente il trattato italo-jugoslavo firmato da Giolitti, con cui Fiume diveniva una città libera. Successivamente ad una discussione del Comitato Centrale dei Fasci del 15 novembre Mussolini modificò la propria opinione sulla bontà del trattato.
Nel gennaio del 1921 la minoranza comunista usciva dal PSI per fondare il Partito Comunista d’Italia; ciò mise in allarme Mussolini perché i socialisti, ricollocatisi su posizioni più moderate, avrebbero potuto essere interpellati da Giolitti per una collaborazione governativa, escludendo in questo modo i fascisti dagli scenari politici principali. Il 2 aprile, dopo aver sfilato con gli squadristi in camicia nera in occasione dei solenni funerali delle vittime del terrorismo anarchico del teatro Diana[senza fonte], Mussolini accettò la richiesta di Giolitti di far parte dei Blocchi Nazionali, contando di poter addomesticare i fascisti alle sue posizioni politiche e utilizzarli per indebolire le opposizioni.
Il futuro Duce si presentò quindi come alleato di Giolitti, dei nazionalisti e di una serie di altre associazioni e partiti, alle elezioni del 15 maggio 1921, nelle liste dei “Blocchi Nazionali” antisocialisti: la lista ottenne 105 seggi, di cui 35 per i fascisti e anche Mussolini fu eletto deputato. Grazie all’immunità parlamentare poté quindi evitare il processo relativo ai fatti del 1919 (cospirazione e detenzione illegale di armi). Le consultazioni si svolsero in un clima di violenza: i morti furono un centinaio e in molte zone, approfittando del tacito favore della Polizia, i fascisti impedirono ai partiti di sinistra di tenere comizi.
In molti si convinsero che ormai dialogare con Mussolini fosse diventato inevitabile: Giovanni Amendola e Vittorio Emanuele Orlando teorizzarono una coalizione di governo che includesse anche i fascisti e Nitti, che sperava nella presidenza del Consiglio, riteneva ora un’alleanza con Mussolini il mezzo migliore per scalzare il suo avversario Giolitti.
Proprio Giolitti, secondo lo stesso Mussolini, era l’unico uomo che poteva evitare il successo del fascismo: Facta lo sollecitò più volte a intervenire ma il grande vecchio della politica italiana comunicò che non si sarebbe scomodato se non per prendere direttamente in mano le redini del governo (fu questo un errore di cui si sarebbe pentito). I fascisti lo blandirono promettendogli la presidenza del Consiglio ed egli li accreditò presso il mondo industriale milanese.
Tra il 27 e il 31 ottobre 1922, la “rivoluzione fascista” ebbe il suo culmine con la “marcia su Roma”, opera di gruppi di camicie nere provenienti da diverse zone d’Italia e guidate dai “quadrumviri” (Italo Balbo, Cesare Maria De Vecchi, Emilio De Bono e Michele Bianchi). Il loro numero non è mai stato stabilito con certezza; tuttavia, a seconda della fonte di riferimento, la cifra considerata oscilla tra le 30.000 e le 300.000 persone.
Mussolini non prese parte direttamente alla marcia, temendo un intervento repressivo dell’esercito che ne avrebbe determinato l’insuccesso.Rimase a Milano (dove una telefonata del prefetto lo avrebbe informato dell’esito positivo) in attesa di sviluppi e si recò a Roma solo in seguito, quando venne a sapere del buon esito dell’azione. A Milano, la sera del 26 ottobre, Mussolini ostentò tranquillità nei confronti dell’opinione pubblica assistendo al Cigno di Molnár al Teatro Manzoni. In quei giorni, stava in realtà trattando direttamente col governo di Roma sulle concessioni che questo era disposto a fare al Fascismo, e il futuro Duce nutriva incertezza sul risultato che la manovra avrebbe avuto.
Il re, per l’opposizione di Mussolini a qualsiasi compromesso (il 28 ottobre rifiutò il Ministero degli Esteri) e per il sostegno di cui il fascismo godeva presso gli alti ufficiali e gli industriali, che vedevano in Mussolini l’uomo forte che poteva riportare ordine nel paese “normalizzando” la situazione sociale italiana, non proclamò lo Stato d’assedio proposto dal presidente del Consiglio Facta e dal generale Pietro Badoglio, e diede invece l’incarico a Mussolini di formare un nuovo governo di coalizione (29 ottobre). Se il re avesse accettato il consiglio dei due uomini, non ci sarebbero state speranze per le camicie nere: lo stesso Cesare Maria De Vecchi e la destra fascista di ispirazione monarchica avrebbero optato per la fedeltà al Re.
Da tutte queste considerazioni l’assoluta originalità del suo discorso dal balcone di Piazza Venezia, direttamente al “popolo italiano”. Un discorso sintetico, privo di errori e sbavature, che in pochissime frasi richiama ai miti del passato, alla fierezza del popolo, pone gli obiettivi dell’azione intrapresa, giustifica la scelta fatta in “colpe” altrui.
Riesce a trasformare in due righe una chiara guerra di aggressione e di invasione in una dichiarazione di guerra di difesa, necessaria e inevitabile anche contro la volontà del duce. Fino all’imperativo categorico di “vincere”, ed all’iperbole concettuale di cominciare una guerra per dare un lungo periodo di pace.
Combattenti di terra, di mare e dell’aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d’Italia, dell’impero e del Regno d’Albania. Ascoltate!
Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevocabili.La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste frasi: promesse, minacce, ricatti e, alla fine, quale coronamento dell’edificio, l’ignobile assedio societario di cinquantadue Stati.
La nostra coscienza è assolutamente tranquilla.
Con voi il mondo intero è testimone che l’Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l’Europa; ma tutto fu vano. Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili per l’eternità; bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie, che si è palesata soprattutto micidiale per coloro che le hanno accettate. Bastava non respingere la proposta che il Führer fece il 6 ottobre dell’anno scorso, dopo finita la campagna di Polonia.
Ormai tutto ciò appartiene al passato. Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi ed i sacrifici di una guerra, gli è che l’onore, gli interessi, l’avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia.
Noi impugnammo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime; noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di quarantacinque milioni di anime non è veramente libero se non ha libero l’accesso all’Oceano
Questa lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della nostra rivoluzione.
È la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l’oro della terra.
È la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto.
È la lotta tra due secoli e due idee.
Ora che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha bruciato alle nostre spalle i vascelli, io dichiaro solennemente che l’Italia non intende trascinare altri popoli nel conflitto con essa confinanti per mare o per terra. Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Egitto prendano atto di queste mie parole e dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno o no rigorosamente confermate.
Italiani! In una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi che, secondo le leggi della morale fascista, quando si ha un amico si marcia con lui sino in fondo. Questo abbiamo fatto e faremo con la Germania, col suo popolo, con le sue meravigliose Forze Armate.
In questa vigilia di un evento di una portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero alla Maestà del re imperatore che, come sempre, ha interpretato l’anima della patria. E salutiamo alla voce il Führer, il capo della grande Germania alleata.
L’Italia, proletaria e fascista, è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai.
La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti.
Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all’Oceano Indiano: vincere!
E vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all’Italia, all’Europa, al mondo.
Popolo italiano! Corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore!