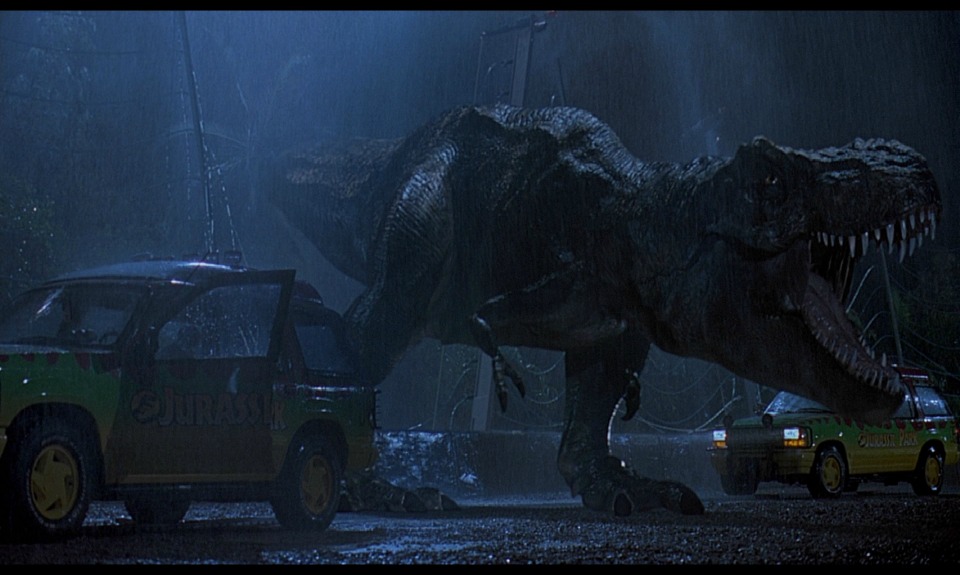Il 21 dicembre 1937 presso il Carthay Circle Theatre di Los Angeles, al termine della proiezione in anteprima di quella che era stata definita una follia, il pubblico, composto tra gli altri da star del calibro di Charlie Chaplin, Shirley Temple, Clark Gable, Judy Garland e Marlene Dietrich, concesse una standing ovation al primo lungometraggio animato della storia. L’artefice di quella follia era Walt Disney e quel film era Biancaneve e i sette nani. All’epoca Walt Disney era un cineasta talentuoso che si era fatto conoscere prima per le Alice Comedies, nei primi anni ’20, e poi, soprattutto, per la serie di Mickey Mouse (dopo aver perso i diritti per Oswald the Lucky Rabbit) e delle Silly Symphonies, cortometraggi animati molto distanti dalle produzioni seriali di Tex Avery o dei fratelli Fleischer (creatori di Betty Boop e Braccio di Ferro).
Mickey Mouse era il simbolo del New Deal, il coraggioso americano che combatteva la paura della Grande Depressione con la positività che era tipica anche del suo creatore, Walt Disney (anche se, secondo alcuni, a disegnarlo sarebbe stato Ub Iwerks). Dall’altro lato c’erano le Silly Symphonies, anch’esse portatrici dei valori del New Deal e già capaci di per sé di rivoluzionare, dal punto di vista tecnico, il cinema d’animazione, ad esempio per l’introduzione della multiplane camera, capace di dare profondità all’immagine (in The Old Mill, 1937) o per aver regalato per la prima volta il colore (in Flowers and Threes, 1932) a delle produzioni fino a quel momento piuttosto spartane e dipendenti dai più importanti lungometraggi live action.
In realtà già qualcuno aveva provato a nobilitare un tipo di cinema che sembrava soltanto il surrogato di quello con attori in carne e ossa. Un primo tentativo l’aveva fatto l’argentino Quirino Cristiani, i cui film furono però distrutti in un incendio; in seguito c’era stata anche Lotte Reiniger con Le avventure del Principe Achmed (1923), realizzato con la tecnica delle silhouette. Ma nessuno di loro era stato in grado di dare ai cartoni animati un’impronta hollywoodiana, così come accadde per Biancaneve e i sette nani. D’altronde anche Max Fleischer – forte concorrente di Disney – avrebbe tentato la stessa operazione due anni dopo, con I viaggi di Gulliver (1939), ottenendo risultati tutt’altro che gratificanti. Gli ingredienti del successo di Disney erano piuttosto semplici, prelevati da una nota fiaba dei fratelli Grimm e riadattati secondo la visione del mondo di Walt Disney: da un lato una fanciulla dal volto e dal cuore candido, orfana prima della madre e poi del padre; dall’altro una matrigna – una regina – gelosa della crescente bellezza della sua figliastra nonché della sua giovinezza e della sua squisita bontà.
Un primo tentativo di affronto: l’ordine a un cacciatore, uccidere la fanciulla e portare il suo cuore in uno scrigno. Ma il cacciatore, impietosito da Biancaneve, la lascia andare e così la fanciulla trova rifugio presso una casetta, al di là del bosco. Qui vivono i sette nani, che all’inizio lei scambia per dei bambini. I nani, i cui nomi rispecchiano le peculiarità caratteriali (Dotto, Gongolo, Eolo, Mammolo, Cucciolo, Brontolo e Pisolo), tornano a lavorare nelle miniere, mentre Biancaneve, calatasi più nel ruolo di ragazza-madre che di principessa, si occupa delle faccende domestiche, con l’aiuto degli animali della foresta, lavando e cucinando. Intanto la regina scopre che il cacciatore non le ha portato il cuore di Biancaneve ma quello di un cinghiale, così decide di muoversi in prima persona per annientare una volta per tutte la sua nemica e per essere lei «la più bella del reame». Ora rivela la sua vera natura: è una strega, una profonda conoscitrice di formule alchemiche mostruose, capaci di tramutarla in una vecchia megera; e capaci anche di trasformare il frutto del peccato originale, la mela – una bellissima mela rossa – in un’arma letale. L’ingenuità di Biancaneve non può nulla contro la furbizia della strega. Giunta alla casetta dei nani, è sufficiente offrirle la mela per assicurarsi che Biancaneve non si tirerà indietro: basta un solo morso per ucciderla.
Nel frattempo, gli animali della foresta corrono alla miniera per richiamare i nani e per avvertirli che Biancaneve è in pericolo. A sconfiggere la strega sarà il Fato, che la farà precipitare sghignazzando da un burrone, mentre tenterà di schiacciare i nani «come formiche». Quanto a Biancaneve, c’è un solo modo per risvegliarla da un sonno tutt’altro che mortuario: il bacio del vero amore, che potrà esserle dato da un giovane, un principe che già aveva dimostrato di amarla, quando aveva ascoltato la sua candida voce mentre raccoglieva l’acqua dal pozzo. Una fiaba con una trama semplice, lineare, con pochi ma essenziali personaggi, ognuno dei quali con una funzione ben precisa: la strega come antagonista, i nani come aiutanti, il principe come risolutore/salvatore; e Biancaneve che, passiva, attende il compiersi della propria sorte. Essere odiata perché lo Specchio Magico rivela alla regina che non è lei «la più bella del reame». C’è invidia, c’è odio, c’è soprattutto la profonda consapevolezza che la fanciulla potrebbe oscurarla. Questo è il moto dell’azione, che si sviluppa attraverso le celeberrime canzoni della Disney, che fanno diventare il film una vera e propria operetta.
Una follia, già. Una follia che nel 1937 trasformò Disney e la sua azienda in colossi cinematografici, con incassi da capogiro, considerata l’epoca. Soltanto Via col Vento, due anni dopo, sarebbe riuscito a fare meglio. Ma Walt Disney non era uno capace di accontentarsi; e così, da vero self-made man, desiderò moltiplicare il proprio successo con qualcosa di ancora più ambizioso. I profitti di Biancaneve lo portarono a realizzare un nuovo studio, a Burbank, dove ora risiedono i Walt Disney Studios. Ma l’inizio della guerra e lo sciopero del ’41, a causa dei numerosi licenziamenti, non gli facilitarono le cose, per cui il film successivo, Fantasia (1940), troppo all’avanguardia per quei tempi, non fu abbastanza apprezzato, pur essendo la geniale unione tra cultura alta e cultura popolare: la musica e il cartoon, o meglio la musica classica e Topolino, simbolo aziendale decaduto, rilanciato nell’episodio L’apprendista stregone dopo che, nei cortometraggi tra la fine degli anni ‘30 e i primi anni ‘40, il successo di Paperino lo aveva quasi oscurato. Paperino era infatti diventato lo strumento di propaganda anti-nazista di Walt Disney, incarnando lo spirito dell’americano per eccellenza, esemplato in un cortometraggio – talvolta male interpretato – come Der Fuherer’s Face, laddove sognava di essere un nazista, per poi risvegliarsi da quel tremendo incubo e baciare la Statua della Libertà.
Film di propaganda, dunque. L’impegno politico di Walt Disney, che sarebbe diventato collaboratore di J. Edgar Hoover nella caccia ai comunisti, è indiscutibile sin dai primi cortometraggi di Topolino, ma anche in Biancaneve non mancano messaggi coraggiosi: l’iperattivismo dei nani è un inno al lavoro. Sono americani che non si perdono d’animo, che anche nei momenti più difficili continuano a lavorare con positività, instancabili. La stessa cosa la fa Topolino, che anzi, come già detto, incarnava l’essenza stessa del New Deal di Roosevelt. Dall’altro lato, come elemento negativo, troviamo il Lupo Ezechiele, che nei Tre porcellini (1933), secondo Ejzenštein, rappresentava la disoccupazione. E non a caso la canzone canticchiata da due dei tre porcellini (quelli più scansafatiche) era “Who’s afraid to the Big Bad Wolf?”, un testo scritto da Frank Churchill e inno del New Deal durante la Grande Depressione, citato anche da Frank Capra in Accadde una notte (1934). Capra, non a caso, era amico di Walt Disney.
Oltre a un forte richiamo alla realtà politica dell’epoca, però, Biancaneve è anche ricco di simboli. Per esempio Biancaneve che invoca l’amore quando raccoglie l’acqua del pozzo, ovvero le emozioni raccolte dal subconscio. E anche le personalità dei nani non sono casuali: si va dall’ingenuità infantile di Cucciolo alla saggezza di Dotto, con Brontolo a simboleggiare l’intolleranza e la vecchiaia e Gongolo e Mammolo negli stadi intermedi dell’innamoramento. Tutte le fasi della vita, scandite in sette personalità diverse. Ma i film di Walt Disney, non soltanto Biancaneve e i sette nani, sono stati interpretati anche in maniera tutt’altro che positiva. La metamorfosi della regina in vecchia, ad esempio, secondo un utente spagnolo di YouTube, alluderebbe a un’invocazione a Satana: «Polvere di mummia, per invecchiare; per tingere le vesti, il nero della notte; per arrochire la voce, risata di strega; per imbiancare i capelli, un urlo di terrore; turbine di vento, per agitare il mio odio». Sono ingredienti che hanno l’obiettivo di terrorizzare lo spettatore e di inquietarlo per il potere oscuro della regina e per le sorti di Biancaneve. Ma se così non fosse stato, se la regina non avesse avuto questi poteri oscuri, il film avrebbe perso interesse e non avrebbe avuto successo.
Pur essendo tratto da una fiaba dei Grimm, il film ha alcune fondamentali differenze che addolciscono il contenuto e che riadattano la storia per il pubblico a cui Disney voleva rivolgersi: le famiglie americane che amano l’entertainment e il dolce sapore del lieto fine. Perché nel mondo di Walt Disney tutto deve finire bene e anche storie profondamente drammatiche come potevano essere il Peter Pan di Barrie (il triste isolamento del bambino in un mondo che gli impedisce di crescere e che lo porterà ad allontanarsi dalla famiglia), o simboliche come il Pinocchio di Collodi – devono avere i tratti tipici della “disneynità”. Per cui, se nella fiaba dei Grimm la strega tenta più volte di uccidere Biancaneve, prima soffocandola con una cintura e poi con un pettine avvelenato, nella Biancaneve di Walt Disney è sufficiente la mela avvelenata; in secondo luogo, il bacio del principe non esiste per i Grimm: Biancaneve si risveglia in maniera del tutto casuale, quando un principe (che non l’ha mai vista se non dopo essere stata avvelenata con la mela) la conduce nel suo castello e nel corso di una caduta Biancaneve riesce a espellere il boccone avvelenato. Niente di romantico, quindi. E anche la punizione del Fato è un’invenzione di Walt Disney: la matrigna, invitata alle nozze di Biancaneve con il principe, è costretta a indossare delle calzature incandescenti e a ballare, finché non muore. Varianti essenziali, come si è già detto, per identificare alcuni elementi con la Biancaneve di Disney, non con quella dei Grimm.
Le trasposizioni più recenti della celeberrima fiaba non fanno altro che restituire alla storia di Biancaneve il tema essenziale che Disney aveva cercato di celare: la sessualità. Perché in fondo la regina vuole uccidere Biancaneve perché è gelosa di lei, della sua bellezza, ma soprattutto della sua femminilità; una femminilità pericolosa perché le può sottrarre il suo sposo. Un elemento che nel film della Disney non è per niente accentuato, cosa che accade invece in Biancaneve (2012) con Lily Collins e Julia Roberts, laddove le due donne arrivano addirittura a contendersi il principe. È chiaro che, anche per il pubblico a cui è destinato Biancaneve e i sette nani (le famiglie, ma soprattutto i bambini, la cui sessualità è ancora latente), due donne che, per conquistare un uomo, esprimono al massimo la propria femminilità non sono affatto concepibili, anche se, nella Sirenetta (1989), questo elemento verrà fuori. Ma si tratta di un periodo differente, e soprattutto con un’azienda del tutto rinnovata e orfana di Walt Disney. Purtroppo le esigenze di marketing portano però anche a una rilettura di fiabe classiche secondo una visione moderna e di genere totalmente diverso che va a snaturare la morale stessa della storia, trasformandola in un futile intrattenimento fine a se stesso. È ciò che accade in Biancaneve e il cacciatore, sempre del 2012, che segue il filone di altre fiabe ritornate al cinema in live action come il deludente Alice in Wonderland (2010) di Tim Burton o come lo pseudo-horror Cappuccetto Rosso Sangue (2011); oppure, infine, l’altrettanto deludente e inutile remake La Bella e la Bestia (2014).
Tornando a quella notte del 21 dicembre 1937, la follia di Disney si era rivelata una scommessa più che vincente: il successo al botteghino per il primo lungometraggio animato della storia, escludendo i tentativi – di cui si è già accennato – di Quirino Cristiani e di Lotte Reiniger, fu straordinario. Walt Disney, due anni dopo, si aggiudicò l’Oscar alla carriera e fu lodato da Chaplin e da Ejzenštein, che definì Biancaneve il più grande film mai realizzato. Tramandato per intere generazioni, amato da ogni famiglia, senza distinzione di sesso o di età, Biancaneve e i sette nani è il più grande classico fra tutti i classici Disney, una pietra miliare della settima arte, innovativo tanto quanto lo sarebbe stato Quarto Potere soltanto tre anni dopo ma molto più popolare. Un’esplosione incontenibile di emozioni, dettate da situazioni anche piuttosto naïf, ma assolutamente originale, se si considera l’epoca in cui è nato. Un film di quasi ottant’anni fa – settantotto, per essere precisi – ma immortale tanto quanto il suo creatore, un uomo che voleva farsi ibernare per ottenere l’immortalità e che è riuscito a salvaguardare il proprio nome, la propria fama, attraverso personaggi innocenti e genuini come dei bambini, divenuti tra i maggiori simboli della cultura popolare, non soltanto di quella occidentale.